Note su arte e verità
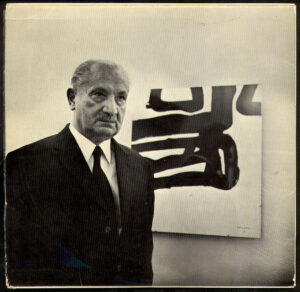 1. L’endiadi «arte e verità» si riaffaccia in modo sintomatico lungo un arco di pensiero teso, come minimo, tra Platone e Heidegger, passando almeno per Aristotele, Hegel, Nietzsche1. Che tale endiadi assuma la forma di una preoccupazione circa la differenza e persino il dissidio tra philosophia e techne poietike (e quindi tra il filosofo e il poeta, dopo il politico e il sofista); oppure di un riconoscimento circa il carattere ben più veritiero della poiesis rispetto a qualsiasi collezione di fatti (e quindi, ad esempio, circa il modo in cui la poesia tragica coglie e mette in scena la verità dell’agire umano e del suo destino, mostrandosi in tal guisa più vicina alla filosofia che non l’osservazione storica); ovvero, ancora, che assuma la forma di un afferramento concettuale della natura dell’arte (e della bellezza) in quanto apparire sensibile dell’idea, cioè di una verità che via via crea e sa se stessa (cosicché, da un lato e rispetto alla religione e alla filosofia, l’arte non è ancora l’ultimo e più essenziale gradino del vero, ma dall’altro – posto che la verità dell’idea, esattamente come il dio che obbedisce a una legge di rivelazione, si procura sempre la sua propria manifestazione – l’arte resta nondimeno e pur sempre una sede del vero a tutti gli effetti); oppure, infine, di un tentativo di rovesciamento della gerarchia enunciata dal platonismo, cosicché non è il filosofo ad essere il compositore della “più bella e ad un tempo della migliore tragedia”, bensì il vero artista, nell’essenziale, ad essere il vero filosofo, e soprattutto è la verità, in quanto tale, a subordinarsi al progetto creatore nel quale la vita afferma se stessa e pone i propri valori; per quanto, insomma, l’endiadi «arte e verità» abbia assunto molteplici configurazioni storico-speculative – costituendo così uno stemma e persino un emblema della tradizione d’Occidente, all’interno della quale sopravanza di gran lunga, in quanto problema e tema di interrogazione, ogni paragonabile preoccupazione che possano aver nutrito per essa altre tradizioni, lontane o differenti, come ad esempio quella indiana e quella cinese, che, pur scavando a fondo nel tema dell’apparire, non hanno mai drammatizzato, almeno nelle loro componenti maggioritarie, la supposta tensione tra verità e arte –, non c’è dubbio, concesso tutto ciò, che la questione abbia impegnato il pensiero di Martin Heidegger in modo talmente cospicuo, complesso e caratteristico, da rendere impossibile una sintesi – per non dire un’appropriazione – del suo pensiero senza passare per la disamina di quell’antico rapporto, ovvero senza affrontarne i nodi e le difficoltà. Facendo peraltro attenzione, si noti, a non confondere tale endiadi – rischiando una sovrimpressione – con l’altro rapporto cruciale del suo Denkweg, ossia la «tenue, ma limpida differenza»2 tra Denken e Dichten, a sua volta irriducibile all’endiadi platonico-aristotelica di philosophia e poiesis.
1. L’endiadi «arte e verità» si riaffaccia in modo sintomatico lungo un arco di pensiero teso, come minimo, tra Platone e Heidegger, passando almeno per Aristotele, Hegel, Nietzsche1. Che tale endiadi assuma la forma di una preoccupazione circa la differenza e persino il dissidio tra philosophia e techne poietike (e quindi tra il filosofo e il poeta, dopo il politico e il sofista); oppure di un riconoscimento circa il carattere ben più veritiero della poiesis rispetto a qualsiasi collezione di fatti (e quindi, ad esempio, circa il modo in cui la poesia tragica coglie e mette in scena la verità dell’agire umano e del suo destino, mostrandosi in tal guisa più vicina alla filosofia che non l’osservazione storica); ovvero, ancora, che assuma la forma di un afferramento concettuale della natura dell’arte (e della bellezza) in quanto apparire sensibile dell’idea, cioè di una verità che via via crea e sa se stessa (cosicché, da un lato e rispetto alla religione e alla filosofia, l’arte non è ancora l’ultimo e più essenziale gradino del vero, ma dall’altro – posto che la verità dell’idea, esattamente come il dio che obbedisce a una legge di rivelazione, si procura sempre la sua propria manifestazione – l’arte resta nondimeno e pur sempre una sede del vero a tutti gli effetti); oppure, infine, di un tentativo di rovesciamento della gerarchia enunciata dal platonismo, cosicché non è il filosofo ad essere il compositore della “più bella e ad un tempo della migliore tragedia”, bensì il vero artista, nell’essenziale, ad essere il vero filosofo, e soprattutto è la verità, in quanto tale, a subordinarsi al progetto creatore nel quale la vita afferma se stessa e pone i propri valori; per quanto, insomma, l’endiadi «arte e verità» abbia assunto molteplici configurazioni storico-speculative – costituendo così uno stemma e persino un emblema della tradizione d’Occidente, all’interno della quale sopravanza di gran lunga, in quanto problema e tema di interrogazione, ogni paragonabile preoccupazione che possano aver nutrito per essa altre tradizioni, lontane o differenti, come ad esempio quella indiana e quella cinese, che, pur scavando a fondo nel tema dell’apparire, non hanno mai drammatizzato, almeno nelle loro componenti maggioritarie, la supposta tensione tra verità e arte –, non c’è dubbio, concesso tutto ciò, che la questione abbia impegnato il pensiero di Martin Heidegger in modo talmente cospicuo, complesso e caratteristico, da rendere impossibile una sintesi – per non dire un’appropriazione – del suo pensiero senza passare per la disamina di quell’antico rapporto, ovvero senza affrontarne i nodi e le difficoltà. Facendo peraltro attenzione, si noti, a non confondere tale endiadi – rischiando una sovrimpressione – con l’altro rapporto cruciale del suo Denkweg, ossia la «tenue, ma limpida differenza»2 tra Denken e Dichten, a sua volta irriducibile all’endiadi platonico-aristotelica di philosophia e poiesis.
2. In questa sede, vorremmo limitarci ad alcune annotazioni sul nesso arte-verità proprio a partire da Heidegger, lasciando sullo sfondo, data la loro ampiezza e articolazione, le molte altre questioni che con quel nesso si intrecciano. Non senza aver prima formulato un’importante premessa relativa alla lingua del pensatore. Prendendo infatti le mosse da interessi di grammatica speculativa e muovendosi nell’ambito di un’appropriazione trasformativa della fenomenologia di Husserl – che fa tesoro, tra gli altri, di decisivi stimoli kierkegaardiani –, Heidegger elabora molto presto una teoria della formazione dei concetti filosofici che pone al centro il tema dell’«indicazione formale»3. A differenza dei concetti ordinari, ivi inclusi quelli scientifici di primo livello (non relativi, cioè, alla chiarificazione dei fondamenti), le parole fondamentali in uso nel discorso filosofico non hanno un carattere oggettivante e tendenzialmente isolato, come implica la prassi di riconduzione dell’essente individuale a una specie e infine a un genere di ordinata appartenenza, bensì funzionano come indici. Hanno cioè natura indicale e persino indiziaria, distribuendosi entro una rete di interconnessioni mobili, talora persino labili. Allorché, tuttavia, questi concetti vengono assunti senza tener conto di questa loro natura operativa (ossia vengono recepiti anzeigefrei, scrive Heidegger), e pertanto ne viene neutralizzata, o più semplicemente non ne viene colta a pieno la dimensione «formalmente indicante» e dunque il ruolo di indicatore che mostra (la Anzeigefunktion), essi decadono a concetti ordinari e cessano di svolgere una funzione propriamente filosofica, collassando per così dire in semplici cristallizzazioni semantiche, punti d’arresto statici e descrittivi, oltreché reificanti, di enunciati proposizionali.
In altri termini, qualora i concetti filosofici siano amputati della loro prestazione deittica, essi depongono la loro struttura d’appello e cessano di rinviare a una dinamica integralmente performativa, legata cioè all’esercizio, in proprio, di uno sguardo fenomenologico che implica e presuppone sempre, esistenzialmente, un evento trasformativo. Se i concetti forniscono e predelineano una direzione a tale sguardo – offrendogli per così dire un binario lungo il quale muoversi –, il compito di percorrere il cammino è sempre e soltanto demandato a chi ascolta o legge il discorso filosofico. Di conseguenza, quei concetti sono realmente efficaci e per così dire in se stessi davvero compiuti, solo nell’evento del loro uso e della loro comprensione. Il destinatario di quei concetti non sopraggiunge ad essi come qualcosa di accidentale. Fa parte di essi in modo strutturale. In breve, è tale destinatario – cioè noi stessi, e non una presunta realtà esterna e oggettiva, protocollata da asserzioni – il significato di tali concetti. Esattamente come l’Apollo delfico, che secondo il fr. 93 di Eraclito «oute legei, oute kryptei, alla semainei», il concetto filosofico non dice apertamente, né occulta nel nascondimento, bensì indica e fa segno, rimettendo la potenza della propria significazione a una significanza in altro, ovvero alla risonanza che il suo responso assume per chi sta, con esso, in un qualche rapporto di concernimento.
Non è un caso, del resto, che Heidegger richiami una ricca articolazione terminologica, relativa all’ampiezza visuale (Sichtweite) del pre-sguardo (Vorblick) e soprattutto al possesso, alla posizione, al campo, alla direzione, al binario dello sguardo vero e proprio (Blickhabe, –stand, –feld, –richtung, –bahn), ma ancor prima alle modalità del giungere, portare, ricevere, afferrare, avere (kommen, bringen, bekommen, nehmen, haben) al e nello sguardo (zum/in den Blick) quel che viene appunto formalmente indicato nel discorso filosofico. Ossia, nel lessico husserliano accolto da Heidegger, il «fenomeno», ciò che, mentre si mostra a partire da se stesso («von ihm selbst her»), è «das Sich-an-ihm-selbst-zeigende», come si legge nella sezione A del § 7 di Essere e tempo: non tanto qualcosa che mostra ‘se stesso’, manifestandosi ‘in’ se stesso – ossia «in ihm selbst», se non addirittura «in sich selbst», nel senso di un «bei sich selbst» che non sarebbe ancora «für sich selbst» –, bensì ciò che non è altro – ‘dentro’ di esso e nella sua intrinseca dinamicità manifestativa, ovvero nel suo An-wesen, inteso come il dimorare in un giungere, come la Annäherung in una Nahnis, di cui il presenziare e il presentarsi non sono che aspetti collaterali – che un mostrarsi soltanto ‘entro’ il suo puro Sich-zeigen.
In quanto «ricerca che si muove primariamente ed esclusivamente in mostramenti»4, la fenomenologia non è altro che l’esercizio di uno sguardo che segue questa deissi fenomenico-mostrativa, facendosi carico dell’intera dinamica che si svolge attraverso l’indicazione (preliminare), l’esplicazione (concettuale) e infine l’appropriazione (esistenziale) di ciò che si mostra. Di qui, l’articolato ripensamento della problematica husserliana della correlazione noetico-noematica5, che conduce Heidegger a una tematizzazione sostanzialmente ‘direzionale’ (legata cioè all’orientamento dello sguardo) del fenomeno, ossia del mostrarsi di un mostrantesi. Il ricorso al termine Sinn, ascoltato non solo e non tanto in termini percettologici e semantici, ma anche e soprattutto in termini di percorso e di direzione – come un senso di marcia – è sintomatico. Il Vollsinn del fenomeno, ossia l’articolata pienezza di tutte le sue irradiazioni o direzioni mostrative, discende dalla comprensione della sua primaria direzione d’accesso (Zugangssinn) e dalla sua connessione di senso, ovvero del suo nesso direzionale (Sinnzusammenhang), conforme al senso (sinnmäßig), che Heidegger illustra in base a tre principali direzioni (di senso), entro le quali, di volta in volta, si può avere accesso a ciò che si mostra, ovvero a ciò che, in se stesso, non è che l’evento di un mostrarsi: Gehalts-, Bezugs-, Vollzugssinn (e talora persino Zeitigungssinn). Ossia, rispettivamente: 1) il ‘contenuto’, il trattenersi da se stesso in una forma raccolta del fenomeno, 2) la relazione intenzionale all’interno della quale è trattenuto e prende dimora lo sguardo, rapportandosi al terminus fenomenico del proprio riferimento, e infine 3) la dinamica temporale, senza la quale né contenuto, né relazione intenzionali hanno realtà alcuna. Heidegger affida questa terza e decisiva dimensione del senso al sostantivo Vollzug e al verbo vollziehen, da non confondersi con Vollendung e vollenden. Lo Zug e lo ziehen ascoltati in quei termini, infatti, rinviano ancora un volta all’impulso direzionale di una forza traente, che non ha il significato statico-acquietante di una finalizzazione o di un completamento, quanto piuttosto quello perficiente-trasformativo, sempre dinamico e aperto, di ciò che, in lingua italiana, possiamo evocare piuttosto come un’attuazione e come un compimento: non già un portare a termine e un perfezionare, concludendo, bensì l’evento del compiere in quanto tale, nel senso di un concreto attuare, effettuare, eseguire un ingresso, che non si schiude altrove che nel suo essere compiuto.
Il Che-cosa del fenomeno e il Come del riferimento intenzionale nel quale esso si offre, hanno ‘senso’ solo ed esclusivamente nel Che (ossia nella temporalità) di quel compiersi dello sguardo (e dell’ascolto) che ne attua, ne effettua e ne esegue, performativamente, l’accesso, secondo gradi e livelli differenti (Vollzugsstufen). Senza di che, ogni concetto filosofico è letteralmente sinnlos: non tanto privo di senso – insensato –, quanto piuttosto privo di direzione e dunque di forza-di-indicazione. Al di là di ogni senso di contenuto o di riferimento, è il senso, ovvero la direzione, del compimento appropriativo-trasformativo, in quanto Grundsinn, a decidere di un’esperienza filosofica, talché, così come il destinatario del concetto è il significato del concetto stesso e non una sua appendice estrinseca, il compiersi dello sguardo che si volge al fenomeno – al suo intrinseco e inostruito mostramento – non è un’aggiunta ‘soggettiva’, bensì la sede e il luogo (l’occasione e lo strumento) dell’evento della manifestazione, che nel prosieguo del proprio pensiero Heidegger ascolterà e penserà in particolare nei termini di uno Entzug, ossia di una forza traente che trattiene in riferimento a sé proprio e soltanto distogliendo da sé, e dunque non semplicemente un sottrarsi e un ritrarsi, de-traendosi per così dire da se stessa, bensì una sottrazione-ritrazione che mostra, manifesta, libera, slancia, fa apparire e persino allontana e abbandona: che svia l’attenzione da sé, proprio e soltanto in questo modo avviando a sé.
Tutti i concetti filosofici hanno, in conclusione, un ufficio di An-zeige, di interna e intrinseca mostratività, che si nega a una presa piena e definitiva, proprio perché implica la messa in moto di uno sguardo, il suo esercizio autonomo e autoliberantesi. Donde il carattere di chiamata o richiamo, ma anche di impulso costante e inesauribile che motiva, in tutta semplicità, il successivo accostamento heideggeriano del dire (Sagen), cioè della lingua del pensiero, non già all’asserzione nel senso della proposizione enunciativa (Aussagesatz), bensì – nella forma di un disdire (Entsagen) e di un dicente non dire (sagendes Nichtsagen) – a una somma dizione (Sage) intesa appunto come indicazione (Zeige) propria di un Dichten inteso in senso originario. Cioè di un dictamen che chiama e raccoglie, ma soprattutto di una nominazione che non oggettiva tramite la parola6, bensì abbraccia finanche una logica sigetica (come tale espressamente evocata alla metà degli anni ‘30), ovvero risale a quel tacere che dimora sempre al fondo di ogni dire essenziale7. Tutte le parole fondamentali del pensiero – essere, esserci, esistere, così come tempo, presenza, morte, evento, mondo, nulla, non meno che unità, forma, materia, idea, sostanza, soggetto, monade, ragione, spirito, volontà – sono formalmente indicanti: ivi comprese le due parole che qui ci interessano, ossia arte e verità.
3. La più celebre indicazione formale dell’«essenza dell’arte» da parte di Heidegger risale alla metà degli anni ‘30, ossia al ciclo di conferenze che sta alla base del saggio intitolato L’origine dell’opera d’arte. In esso, l’arte è precisamente abbinata alla verità come sua specifica «messa-in-opera»8. Questa locuzione viene valorizzata nella sua essenziale ambivalenza. Da un lato, lo Ins-Werk-Setzen rinvia al ruolo dell’artista, inteso come colui che, fissando la verità in figura (ossia dando forma all’opera), non è che il tramite dell’installarsi (sich einrichten) della verità entro l’opera, dell’urto che essa suscita e della riconfigurazione linguistica che essa produce. Dall’altro, la locuzione rinvia ai Bewahrende, ossia a coloro che custodiscono, salvaguardano e letteralmente inverano l’opera d’arte, facendosi strumento del suo carattere istituente (stiftend), il che significa donativo, fondativo e incoativo, posto che l’espressione sopra citata non significa semplicemente porre o collocare qualcosa all’interno di qualcos’altro, bensì, parimenti, mettere all’opera nel senso di «porre in moto» e di «condurre ad accadere»9. Ossia ancora, nella fattispecie, di consentire alla verità di avviarsi verso un effetto o un’efficacia, di far sì che essa diventi un autentico accadimento (Geschehnis).
Più propriamente, scrive Heidegger, quello che l’istituente inveramento dell’opera abilita è il dispiegarsi di ciò che è formalmente indicato come il suo essere-opera (Werksein), ossia di quella specifica modalità dell’essente che è distinta dall’essere-cosa e dall’essere-mezzo, e più in particolare dall’essere-oggetto. L’essere-opera è un che di preliminarmente indicato (Angezeigte) soltanto grazie all’esercizio e al compimento di uno ständiger Ausblick, cioè di un costante e mai intermesso sguardo – insieme prospettico e panoramico – sui due tratti essenziali (Wesenszüge) dell’opera10, che sono al contempo i due aspetti secondo i quali si dispiega, grazie a coloro che custodiscono l’opera interrogandola e fruendola, il suo essere: da un lato vi è il suo «esporre un mondo», ossia il dominio storico nel quale si fronteggiano estaticamente l’umano e il divino – il mortale e la sua controparte immortale –, dall’altro vi è il suo «deporre qui la terra», secondo la denominazione che Heidegger utilizza per ascoltare l’impensato dell’antica physis nominata da Eraclito nel fr. 123, ossa lo schiudersi inteso come il «sorgere che rientra in se stesso»11 e insieme un «rientrare-in-se-stesso che sorge»12, e dunque un chiudersi che, nondimeno, si mostra precisamente in questa sua ritraentesi e indisponibile chiusura, resistendo così all’apertura di un mondo storico. Un mostrarsi, dunque, che scaturisce solo ed esclusivamente da un ritrarsi.
Questa diade essenziale di esposizione e deposizione, di mondo e terra – di apertura che si slancia al di sopra di una chiusura e di chiusura che emerge dalle sue profondità nell’aperto – è ulteriormente precisata come un polemos, come una «lotta»13, ossia, insieme, come un conflitto e una coappartenenza di due elementi, e soprattutto come il vincolo di un Gegeneinander (un dimorare l’uno-contro-l’altro nel disporsi l’uno-incontro-all’altro) che fa di essi un due-in-uno, sottolineando la reciprocità del rispettivo concedersi essenza: non solo perché non c’è apertura senza chiusura (e viceversa), ma anche perché l’apertura, nella sua parzialità, è anche chiusura, e la chiusura, affiorando e imponendosi come tale, deve essere a suo modo un’apertura. Mondo e terra (insieme all’essere esponente-deponente dell’opera) vivono l’uno dell’altra e vengono indicati come die Gegenwendigen14, ossia, appunto, i rivolgentisi (contra-stanti) nel senso appena chiarito. Il porsi in opera della verità attraverso il fare dell’artista (la messa in opera) non può dunque fare a meno della messa all’opera dell’opera entro una custodia che consente all’opera stessa di farsi evento di verità, luogo e gioco di uno spazio-tempo non astratto, che assume pertanto la forma storica di una vicendevole immorsatura e al contempo di una pulsazione di terra e mondo.
Ora, dopo aver indicato formalmente l’«essenza dell’arte» in quanto ‘duplice’ messa in opera della verità, offrendo allo sguardo la sua consegna e invitandolo ad esperire, nominare e pensare l’arte stessa a partire da quella indicazione, il passo successivo, indubbiamente più articolato e complesso, consiste nell’indicare formalmente l’«essenza della verità». In estrema sintesi, anche la verità viene abbordata da Heidegger come un Gegeneinander e anzi come il Gegenwendige15 per eccellenza di due ‘elementi’, che appaiono fin da subito l’originaria matrice della lotta di mondo e terra, apertura e chiusura, ossia Lichtung e Verbergung. Tali termini rinviano all’ascolto in brisura16 della parola greca aletheia, nella quale risuonano, contemporaneamente, un’istanza di velamento (lethe) e un’istanza di s-velatezza (a-letheia), ovvero di dis-ascosità e di dis-occultamento. Sennonché, Lichtung e Verbergung vanno ascoltate anch’esse in senso duplice. Se la prima è, insieme, il diradarsi (Sichlichten), ossia un diradamento, e la sua specifica radura, cioè il luogo (lo spazio-tempo) di tale evento di diradamento, la seconda è un velarsi (Sichverbergen) inteso come l’evento processuale di un velamento che non fa che preservare l’essere o il restare velato (Verborgensein), cioè il dimorare entro una velatezza (Verborgenheit) che è «più antica di ogni manifestazione»17. Concepita come la svelatezza (Unverborgenheit) che scaturisce da un disvelamento (Entbergung), o addirittura da una disvelanza (Entbergsamkeit) – non possiamo soffermarci, in queste sede, sulle cruciali sfumature di questi termini, né sui luoghi del corpus heideggeriano in cui vengono enunciati e valorizzati, insieme alle sterminate forme del velamento –, la verità è allora concepita da Heidegger come l’orizzonte più ampio e originario, l’evento o la dinamica, che precede, condiziona e fonda la più tradizionale nozione di «verità» legata alla verifica di un’adeguata corrispondenza o conformità tra parole e cose, pensiero e realtà. Più originaria di qualsiasi correttezza (Richtigkeit), già sempre istituita, è la verità come istituzione (Einrichtung), ossia l’accadere dell’apertura all’interno del quale si installano le singole conformazioni del vero e si dispiegano le relative veridizioni, ossia le pratiche veritative degli individui e delle comunità storiche. Questo dispositivo di verità – questo due-in-uno ‘composto’ di inarticolato e articolato, di sfondo e primo piano, distinti e irriducibili, ma mai separabili – non è che la differenza (che è insieme l’intersezione) tra l’essere (che si vela nella manifestazione) e l’ente (che, solo grazie a quel velarsi, può mostrarsi come tale).
Ancora una volta, l’indicazione dell’arte come messa in opera della verità che assume la forma di una salvaguardia dell’opera, ossia di un’accensione della lotta di terra e mondo come tensione e insieme come rapporto scambievole di una dimensione svelante(si) e di una velante(si), deve compiersi nel nostro sguardo, ossia deve abilitarci a guardare le più disparate concrezioni del fare artistico, scorgendo in esse la misura e l’autenticità di quell’originario conflitto manifestativo, che segna l’appartenenza destinale tra arte e verità. Ma tale indicazione configura altresì un vincolo peculiare tra la verità e l’arte, che nel corso dei decenni Heidegger sottoporrà a un certo numero di riformulazioni18. Tra queste, si può richiamare corsivamente una tarda conferenza del 1967 intitolata La provenienza dell’arte e la destinazione del pensare19, in cui a tema non è più l’arte come origine (Ursprung), e quindi come provenienza dell’essenza (Wesensherkunft), dell’opera e dell’artista20, bensì la Herkunft dell’arte stessa. Se nella cornice del saggio risalente agli anni ‘30, l’arte si rapportava alla verità nei termini della sua duplice messa in opera – e dunque del creare e salvaguardare le opere d’arte, nel senso del fare spazio a un evento e a un’esperienza di verità tendenzialmente riferiti a quella che il giovane Heidegger avrebbe chiamato una direzione di contenuto (Gehaltssinn), quelle che le opere mostrano, il ‘che cosa’ dicono –, nei decenni successivi, l’arte si rapporterà sempre di più alla verità come a un orizzonte dal quale essa stessa, semplicemente, fluisce o scaturisce. Nella conferenza del 1967, infatti, il senso della «provenienza» non è semplicemente riferito alla Grecia come luogo di un’origine storica e di una genesi delle arti occidentali poi divenute belle arti, bensì all’aletheia in quanto tale. Prima ancora di metterla in opera – ‘consentendo’ così alla verità di farsi contenuto (il che significa, di slanciare un mondo in tutta la ricchezza sostanziale dei suoi chiaroscuri, e di rinviare alla terra come alla silenziosa natura che ogni cultura, incessantemente, assume e rielabora in quanto riserva di senso, secondo quanto indicava già, del resto, la diade di Geworfenheit ed Entworfenheit in Essere e tempo, ovvero la collisione, ma anche l’interpenetrazione, tra la gettatezza e la progettualità dell’esistenza) –, l’arte discende dalla verità e non cessa di dispiegarsi in un costante retro-riferimento ad essa.
4. Ma che cosa significa, allora, questa più decisa sottolineatura del nesso ‘derivativo’ tra verità e arte? Forse un platonismo di ritorno, che subordina ogni ordinata apparenza della bellezza artistica a una verità di cui l’arte non sarebbe che concreta intuizione sensibile e insieme involucro imperfetto? Qualora si pervenisse a tali conclusioni, si dimenticherebbe, ancora una volta, il carattere formal anzeigend di tutte le nozioni messe in campo fin qui da Heidegger. Si fraintenderebbe cioè la verità stessa nella direzione di un Che-cosa, anziché del Che del suo Come, ovvero dell’evento della sua dis-velanza, che non mette da parte il velamento – il non-più e il non-ancora di tutto ciò che è s-velato, l’immemorabile dal quale essa proviene e al quale anche fa ritorno –, ma si definisce in rapporto ad esso. Ad essere in questione, qui, non è un’arte che dia forma e sostanza a una verità meramente contemplata, che sussiste e pre-esiste come tale in modo autonomo al di là del suo proprio accadimento storico-temporale, bensì un’arte che definisce se stessa solo ed esclusivamente all’interno del due-in-uno di Lichtung e Verbergung, del diradarsi della sua esposta radura e del velarsi di ciò che in essa è velato, salvaguardato, protetto e infine persino dimenticato.
Nel trattato inedito Vom Ereignis, il cui piano fu concepito nello stesso periodo delle conferenze sull’opera d’arte, anche se fu poi redatto in seguito (1936-1938), Heidegger sottolineava, tra le altre, due cose. In primo luogo, i modi di porre in rapporto la Lichtung con il velarsi (Sichverbergen) del velantesi (Sichverbergende), ossia con il velamento (Verbergung), sono a loro volta due. La verità non è solo Lichtung per (für) o verso (zu) il velamento, bensì del (der/des) velamento e del velarsi. Ossia, in modo analogo alla radura boschiva (Waldlichtung) cara a Heidegger, la Lichtung non è solo luogo, spazio, tempo che accoglie il velamento, ma è l’intero farsi luogo, spazio e tempo – cioè, appunto, il diradarsi – del velamento stesso, dell’indiradato e indiradabile. Come ogni comune radura, che è il luogo chiaroscurale di una luce interna all’oscurità di una selva, resta proprio per questo riferita ad essa e circondata da essa, vivendo per così dire di essa, anche la luce dell’arte è un fendersi del buio, ossia una modulazione dell’oscurità, la quale pertanto viene ad essere paradossalmente la sorgente della vera luce, la luce più originaria, quella che non si vede, ma che sta al cuore di ogni evento (luogo, spazio, tempo) da essa illuminato, analogamente al centro del fuoco, al cuore della fiaccola o al lume di una candela, ossia alla buia incandescenza della fiamma. Comprendendo il diradamento come volgersi o flettersi «del» velamento, si può allora tornare al senso autentico del sintagma «per il velamento» (a servizio e a favore di esso, e insieme in direzione di esso), nel quale ora non parla più soltanto lo stare a disposizione per il più antico velarsi, ospitandone e custodendone il disvelamento, bensì l’essere-per (leggi: dell’arte nei confronti della verità), in tutta la complessità – temporale, spaziale, modale e finanche causale e finale – della preposizione «per». La luce della radura sta ‘per’ l’oscurità, ne prende il posto, e in certo modo la oscura, ma così facendo si rivela precisamente come un modo dell’oscurità e resta pertanto velatamente devoluta ad essa, essendo costantemente in essa. La verità non è che lichtende Verbergung e l’arte, ogni arte, ne è un emblema.
Nondimeno, ed ecco la seconda precisazione introdotta da Heidegger, la «verità come Lichtung für die Verbergung è un progetto essenzialmente diverso rispetto all’aletheia, benché quello, nella rammemorazione, appartenga a questa, e questa a quello»21. La verità, esperita, nominata e pensata come Lichtung, non coincide infatti con l’aletheia, sebbene sia attinta soltanto grazie al ripensamento di essa, ovvero grazie a ciò che, in essa, la tradizione ha lasciato impensato, e sebbene, una volta effettuato tale ripensamento, l’aletheia venga a mostrarsi come qualcosa che appartiene a una più originaria Lichtung, all’evento di un diradamento che, prima ancora di essere posto in opera e insieme messo all’opera come arte, si pone come la provenienza di ogni arte, facendo di essa, essenzialmente, nient’altro che una fragile creazione di radure, e soprattutto una pratica del diradamento, al fondo del quale dimora sempre e comunque un mai soggiogato velamento.
5. Giunti a questo punto, è allora possibile indicare un ‘compito’, qualora si voglia tentare – in relazione al fenomeno della verità in quanto Lichtung – di curvare il senso e la direzione del contenuto e del riferimento (Gehalts-, Bezugssinn) dell’opera d’arte, ciò che essa mostra e il modo in cui noi ci rapportiamo al suo mostramento, verso un più originario senso o direzione di attuazione e di compimento (Vollzugssinn) della sua essenza. Non già per sillabare Heidegger – cosa che pure resta oggi necessaria, anche a fronte della trascuratezza con cui talora ci si accosta alla sua lingua e più in generale al corpus del suo ‘discorso’ complessivo, dalla cui lettura integrale, a differenza di quanto accade per Platone, Aristotele, Hegel, Nietzsche, ci si sente talora esonerati in nome di un’‘interpretazione’ sovente restrittiva –, bensì per tentare di pensare con e a partire da Heidegger. Il che significa: per percorrere in proprio la traiettoria della sua indicazione del rapporto tra arte e verità, onde pervenire, fenomenologicamente, a un suo possibile termine deformalizzato (entformalisiert)22.
Sul quale, in conclusione, non è possibile che un cenno. Non sarebbe soltanto auspicabile, infatti, oltrepassare la ‘sistematica’ (ancora sostanzialmente hegeliana) a cui Heidegger fa riferimento con la progressione Bau-, Bild-, Ton-, Sprachkunst – termini da lui preferiti a quelli di architettura, scultura, pittura, musica, letteratura –, e precisamente in direzione di ambiti ulteriori e oggi decisivi, dall’audiovisivo all’arte digitale. Sarebbe piuttosto e altrettanto proficuo ampliare l’ascolto heideggeriano della Dichtung originaria (quella che va da Omero e Pindaro fino a Hölderlin e Rilke) in direzione di un’analisi discorsiva dell’opera d’arte ‘letteraria’, la quale si volga non soltanto al rapporto tra terra e mondo contenuto in essa (magari nella forma di un’analisi dell’epica romanzesca o dell’affresco di una vita e di un’epoca storica, fosse anche la nostra), oppure, ancora, alla modalità essenzialmente estetologica delle forme di esperienza vissuta delle opere e dei riferimenti intenzionali della loro fruizione, bensì al coglimento attuativo della struttura e in ultima analisi alla direzione di compimento di quello che Heidegger chiamava il Wesensbau, cioè la costruzione essenziale dell’arte e dunque delle opere che sono dell’arte, nel duplice senso del genitivo. In quella dinamica di compimento rientrano temi verso i quali si è già incamminata la meditazione fenomenologica23 e che oggi, dopo la stagione dello strutturalismo, sono ampiamente dibattuti, ad esempio, in ambito narratologico – dal velarsi o dissimularsi della voce narrante all’articolazione non lineare di occultamento e disvelamento nel dispositivo testuale, dal diradamento della densità sintattica all’autochiusura e all’oscuramento come componenti essenziali della narrazione –, ma anche temi sui quali si è esercitata la riflessione extra-occidentale sull’arte – a partire da quella indiana: dal nesso tra implicitazione del significato e risonanza del verso poetico fino alla considerazione della letteratura come teatro senza scena, ossia come manifestazione che riposa su una sottrazione –, temi, in conclusione, che costituirebbero, assieme a molti altri, orizzonti di ricerca fecondi e promettenti per una riflessione di carattere teoretico sulla letteratura. La quale, al di là delle celebri analisi dedicate da Heidegger al tempio greco, piuttosto che alle scarpe di Van Gogh o agli inni di Hölderlin, potrebbe mostrare in che modo e in che senso le arti del linguaggio, e non solo esse, esibiscano una provenienza essenziale dalla verità, intesa come il compiersi di una Lichtung del, per e verso l’irriducibile velamento che sta al fondo di ogni evento di manifestazione e in definitiva della nostra stessa esistenza.
Note
1 Cfr. Montani, 2002.
2 Heidegger, 1979a, p. 185.
3 Per un’ampia disamina teoretica, con relativa bibliografia secondaria, cfr. A. Ardovino, 1998; 2016; 2022.
4 Heidegger, 1992, p. 560.
5 Su cui cfr., tra gli altri, Volpi, 1984.
6 Cfr. Heidegger, 1986, p. 328: «È importante introdurre una distinzione di fondo a proposito del parlare, ossia separare il puro nominare (onomazein) dall’enunciare (legein ti kata tinos). / Nella semplice nominazione io lascio che ciò che giunge nella presenza (das Anwesende) sia ciò che è. Indubbiamente la nominazione implica ciò che nomina – ma il carattere peculiare della nominazione è proprio che chi nomina interviene in essa soltanto per passare in secondo piano davanti all’essente. Allora l’essente è puro fenomeno. / Nell’enunciato, al contrario, colui che enuncia partecipa in quanto interviene – e interviene come colui che si china sull’ente per parlare su di esso».
7 Cfr. Heidegger, 1985, p. 423: «Il più alto dire pensante consiste non semplicemente nel tacere ciò che, nel dire, è autenticamente da dire, bensì nel dirlo in modo tale che esso, nel non dire, sia nominato (genannt): il dire del pensiero è un tacere. Questo dire corrisponde anche all’essenza più profonda della lingua, che ha la sua origine nel tacere. In quanto tacente, il pensatore, a modo suo, assume il rango del poeta (Dichter) e tuttavia rimane eternamente separato da lui, così come il poeta, viceversa, dal pensatore». Da questo punto di vista, le conclusioni che sono state tratte sul discorso di Heidegger da Jaspers e Habermas non sono che lo specchio deformato dell’indicazione formale, gravato però da un giudizio ideologico. Se il primo, ben comprendendo che il tema della Sprachlichkeit filosofica di Heidegger non è mai il Gehalt, si è spinto, come in parte farà anche Adorno, a parlare di una Denkungsart «non libera, dittatoriale, non comunicativa» (Heidegger-Jaspers, 1990, p. 272), il secondo, riconoscendo sulla scorta di Carnap la «propositional gehaltlose Rede vom Sein» (Habermas, 1985, p. 168), si è impegnato in una serie di qualificazioni espressamente dispregiative, riprese e a amplificate poi da diversi interpreti, per i quali il pensiero di Heidegger sarebbe magico, esoterico, autoritario, auratico, profetico, pseudo-sacrale, antidemocratico, coercitivo.
8 Heidegger, 1977a, p. 44.
9 Ibidem. Per un approfondimento di questo tema in rapporto all’essenza dell’arte come Stiftung cfr. Ardovino, 2023b.
10 Cfr. ivi, p. 29.
11 Heidegger, 1979b, p. 371.
12 Heidegger, 1981, p. 56.
13 Heidegger, 1977a, p. 35.
14 Ivi, p. 51.
15 Cfr. ivi, pp. 42, 48, 49.
16 Sul senso di questa espressione cfr. Ardovino, 2022b.
17 Heidegger, 1996, pp. 193-194.
18 Per una panoramica sul tema cfr. Ardovino, 2023a.
19 Cfr. Heidegger, 2020, pp. 1309 sgg.
20 Cfr. Heidegger, 1977a, p. 1.
21 Heidegger, 1989, p. 350.
22 Cfr. Heidegger, 1977b, pp. 47, 321.
23 Cfr. ad es. Iser, 1984.
Riferimenti bibliografici
Ardovino, Adriano. 2023a. «L’opera d’arte», in A. Fabris (a cura di), Heidegger. Una guida, Carocci, Roma: 153-182.
Ardovino, Adriano. 2023b. «Il quadrato dell’arte. Considerazioni di struttura su Der Ursprung des Kunstwerkes di Martin Heidegger» Logoi.ph IX (21): 123-146.
Ardovino, Adriano. 2023c. «Bemerkungen über das Verhältnis von Dichten und Denken bei Heidegger», in H. Seubert, K. Schippling (hrsg.v.) »…was bleibet aber …«. Heidegger – Dichtung und Kunst, Alber, Freiburg i.Br. (in corso di stampa).
Ardovino, Adriano. 2022a. «Metodo indicativo», in R. Lanfredini (a cura di), Filosofia: metodi e orientamenti contemporanei, Carocci, Roma: 163-178.
Ardovino, Adriano. 2022b. «Ureigener Genitiv. Appunti di grammatica speculativa» Logoi.ph VIII (19): 192-216.
Ardovino, Adriano. 2016. «Indicazione, esplicazione, appropriazione. Heidegger e il discorso della fenomenologia», in Id., Interpretazioni fenomenologiche del cristianesimo, LUP, Roma: 9-58.
Ardovino, Adriano. 2004. «Presentazione», in M. Heidegger, Dell’origine dell’opera d’arte e altri scritti, Centro Internazionale Studi di Estetica, Palermo: 7-29.
Ardovino, Adriano. 1998. Heidegger. Esistenza ed effettività – Dall’ermeneutica dell’effettività all’analitica esistenziale (1919-1927), Guerini, Milano.
Habermas, Jürgen. 1985. Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen, Suhrkamp, Frankfurt.
Heidegger, Martin. 2020. Vorträge. Teil 2: 1935–1967, Klostermann, Frankfurt a.M.
Heidegger, Martin. 1996. Wegmarken, Klostermann, Frankfurt a.M.
Heidegger, Martin. 1992. Platon: Sophistes, Klostermann, Frankfurt a.M.
Heidegger, Martin. 1989. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), Klostermann, Frankfurt a.M.
Heidegger, Martin. 1986. Seminare, Klostermann, Frankfurt a.M.
Heidegger, Martin. 1985. Nietzsche, Klostermann, Frankfurt a.M.
Heidegger, Martin. 1981. Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, Klostermann, Frankfurt a.M.
Heidegger, Martin. 1979a. Unterwegs zur Sprache, Klostermann, Frankfurt a.M.
Heidegger, Martin. 1979b. Heraklit, Klostermann, Frankfurt a.M.
Heidegger, Martin. 1977a. Holzwege, Klostermann, Frankfurt a.M.
Heidegger, Martin. 1977b. Sein und Zeit, Klostermann, Frankfurt a.M.
Heidegger, Martin – Jaspers, Karl. 1990. Briefwechsel 1920-1963, Piper-Klostermann, München-Frankfurt a.M.
Iser, Wolfgang. 1984. Der Akt des Lesens, Fink, München.
Montani, Pietro (con A. Ardovino e D. Guastini). 2002. Arte e verità dall’antichità alla filosofia contemporanea. Un’introduzione all’estetica, Laterza, Roma-Bari.
Volpi, Franco. 1984. «La trasformazione della fenomenologia da Husserl a Heidegger» Teoria IV (1): 125-162.
Nessun commento