Il Dio dei mafiosi
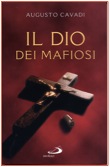 Giulio Piazza: Il tuo Il Dio dei mafiosi, edito dalla San Paolo, ha suscitato in me degli interrogativi. Ovviamente dall’angolazione -in cui tu l’hai scritto ed io l’ho letto- di filosofi attenti a ciò che accade nel nostro tempo. La prima osservazione è relativa alle prospettive culturali siciliane. Ne hai individuato tre più rilevanti (cattolica, borghese- capitalistica, mafiosa) per vederne le reciproche relazioni: non è chiaro però se la lettura che dai della transcultura borghese–capitalistica sia di tipo consumistico o se non consideri anche il suo senso del valore del lavoro, della libertà, del rispetto degli individui, che pure sono frutto della concezione borghese del vivere.
Giulio Piazza: Il tuo Il Dio dei mafiosi, edito dalla San Paolo, ha suscitato in me degli interrogativi. Ovviamente dall’angolazione -in cui tu l’hai scritto ed io l’ho letto- di filosofi attenti a ciò che accade nel nostro tempo. La prima osservazione è relativa alle prospettive culturali siciliane. Ne hai individuato tre più rilevanti (cattolica, borghese- capitalistica, mafiosa) per vederne le reciproche relazioni: non è chiaro però se la lettura che dai della transcultura borghese–capitalistica sia di tipo consumistico o se non consideri anche il suo senso del valore del lavoro, della libertà, del rispetto degli individui, che pure sono frutto della concezione borghese del vivere.
Augusto Cavadi: Hai colto un’ambivalenza che rispecchia l’ambivalenza ‘oggettiva’ di ciò che analizzo. La visione ‘borghese-capitalistica’ ha valenze positive e valenze negative. Ed è proprio per questo che può intrecciarsi con la prospettiva ‘mafiosa’.
G.P. Mi pare chiaro che il centro del libro sia il rapporto tra la religione cattolica e la mafia: in primo luogo prendi in considerazione quale concetto di Dio traspare dalle dichiarazioni degli stessi mafiosi; in secondo luogo quale relazione possa esserci tra il Dio dei mafiosi e il Dio della tradizione cattolico-mediterranea, per il tramite della cultura meridionale; infine, prospetti una differente teologia, più aderente, secondo te, al messaggio evangelico, e perciò più distante dalla visione mafiosa. Se preti come don Puglisi o don Diana sono stati capaci di condannare la criminalità mafiosa, perché però la stessa condanna è venuta con titubanza e dopo molto tempo dalle gerarchie ufficiali? Qui la risposta è chiara: «La teologia para-mafiosa (o, per lo meno, non refrattaria alle riletture mafiose) è prodotto e sintomo, oltre che concausa, di una Chiesa filo-mafiosa (o, per lo meno, non schierata contro i poteri mafiosi)». E tuttavia non si tratta semplicemente di un problema di collusioni pratiche, bensì, parrebbe di capire, di connivenze teoriche: tra istituzione cattolica e mafia potrebbe esserci stata la condivisione, e perciò la difesa, di una comune visione teologica, ed il problema che il libro pone è quanto questa fosse comune. Se entrambe le concezioni s’incontrano nella cultura ‘meridionale’, cosa le può distinguere? Cosa ha impedito – se l’ha impedito – alla teologia cattolica di essere mafiosa? O di essere mafiogena?
A.C. Se la teologia cattolica non s’identifica con la teologia dei mafiosi è perché essa non ha perduto totalmente memoria dell’annunzio evangelico delle origini. Il cordone ombelicale, mai del tutto tagliato, fra il grembo delle origini e la teologia cattolica odierna spiega inoltre, perché sarebbe esagerato definire “mafiogena” la Chiesa cattolica. Nel libro cerco di essere meno approssimativo: la cultura cattolica ha prestato alla mafia simboli, codici, norme, credenze…ma da questo a farne l’unica causa, o la causa decisiva, della mafia, ne corre …
G.P. Sostieni che il dio nella visione dei mafiosi e il dio nella visione cattolico-mediterranea hanno in comune l’idea dell’essere divino come fondamento non fondato, principio di una necessità insuperabile, matrice di un destino arbitrario. Per effetto dell’inculturazione della fede cristiana nell’ambiente greco-romano, il cristianesimo avrebbe partorito una teologia cattolico- mediterranea: essa si nutre di categorie ontologiche e giuridiche che non appartenevano alla concezione biblica. Dunque è all’ambito greco-romano che viene attribuito questo senso dell’ineluttabile, che chiami col nome di nichilismo, ed interpreti come derivazione dell’essere dall’assurdo.
A.C. Beh, veramente non mi riconosco in pieno in questa ricostruzione delle mie paginette. I Greci tutto sono stati tranne che nichilisti. Löwith ha chiarito bene che il nichilismo è figlio (degenere, se vogliamo) del creazionismo ebraico-cristiano-islamico. Ma, a parte la terminologia, accetto la tua sintesi: la Bibbia ebraico-cristiana è animata dalla speranza del novum ed è solo a causa del filtro greco-romano (stoicismo in primis) che viene ritradotta, dal cattolicesimo mediterraneo, in categorie fatalistiche.
G.P. Qui sta, tuttavia, il nodo centrale che si può esprimere attraverso diverse questioni. La prima: l’operazione di potere ideologico, prima che politico, compiuto dalle gerarchie ecclesiastiche dei primi secoli. Perché assolvi con un “inavvertitamente” i padri della chiesa che hanno operato questa «traduzione» o tradimento? L’adattamento del messaggio cristiano alle categorie mentali dell’impero romano risponde inizialmente ad intenti di proselitismo, che si trasformano, in epoca costantiniana, in un chiaro disegno di potere (la condanna di Ario ordita da Attanasio fu un patto di alcuni vescovi con Costantino, il quale decise d’autorità gli esiti del Concilio di Nicea) e di una giustificazione ontologica delle gerarchie sociali e politiche attraverso le gerarchie ontologiche. Che tutto ciò fosse inavvertito è poco credibile.
A.C. Capisco il senso della tua obiezione, ma non saprei se accettarla. Noi filosofi abbiamo a che fare con le idee prodotte da chi ci ha preceduto e dai nostri contemporanei: non abbiamo strumenti per decifrare le intenzioni con cui tali idee sono state elaborate. L’ellenizzazione del messaggio biblico è stata politicamente fruttuosa: basta questo per affermare che si è trattato di un’operazione consapevole, avvertita, intenzionale? Che Giustino e Ireneo, Ambrogio e Agostino – per non parlare dei Cappadoci – sapessero di stare stravolgendo (in meglio o in peggio, qui non importa) l’annunzio che avevano ricevuto da profeti palestinesi? Posso dirti solo che preferisco sospendere il giudizio sulla coscienza, psicologica e morale, di questi patres. Certo, se – come sostieni tu – sapevano ciò che facevano, la loro responsabilità davanti a Dio è immensa.
G.P. Una seconda domanda è sul significato di una trascendenza divina introdotto, sia pur in linguaggio non ontologico, dall’esperienza di fede biblica. Nella traduzione ontologica del cristianesimo si precisa il senso della creazione come pura gratuità dal nulla. Anche questo è un tradimento? È certo che questa concezione non era presente nella cultura greca, e che il primo a prendere le distanze dalle teorie greche, in questo senso, è stato già Filone d’Alessandria. È nel concetto di creazione che si pone il nulla tra il principio e la natura, per cui la natura non sarebbe se non per la volontà del creatore. La natura è la realizzazione di una possibilità che non dipende da sé, ma da altro.
A.C. Il creazionismo – come lo hanno insegnato Agostino o Tommaso d’Aquino – è uno dei tanti modi possibili per leggere le pagine della Genesi biblica. Non solo non è l’unico modo ma, stando agli esegeti di formazione ebraica, non è neppure il più corretto e adeguato: Jahvé interviene a giocare su un caos primordiale del quale non è l’autore originario, radicale. Ciò detto, va aggiunto che la discussione non incide sul messaggio biblico più di quanto la discussione della cosmologia leopardiana incida sulla ricezione delle liriche del recanatese. La Bibbia ci dice che Qualcuno si occupa dell’universo e si preoccupa di ogni figlio di uomo, di ogni uccellino sul nido, di ogni filo d’erba: stop. E’ poco? A me pare anche troppo! Davanti allo spettacolo millenario di sofferenze infinite, sperimentate momento dopo momento da viventi di ogni specie, non è certo facile evitare quello che ritengo l’autentico nichilismo: la teoria (nicciana) che in principio era l’Assurdo e che tutto è retto sull’Assurdo. Ritenere che in principio c’è, invece, un Logos (un Senso, una Ragione) – come sostenevano Eraclito, Filone d’Alessandria o l’autore del vangelo secondo Giovanni – è molto più arduo: ma è con questa convinzione che, a mio parere, sta o cade la fede in senso religioso autentico. Questo è il motivo per cui sono convinto che molti che credono di essere atei sono profondamente religiosi e molti che credono di essere credenti sono radicalmente privi di senso religioso.
G.P. Restano, comunque, le mie forti riserve. Il discorso tuo mi appare problematico giacché è vero che il tragico greco afferma l’ineluttabilità dell’uomo di fronte alla moira, ma è concezione che viene inserita comunque all’interno di una visione dell’essere. Il non senso del nichilismo greco (anteriore a Socrate e Platone, ma presente ancora nelle filosofie ellenistiche), se nichilismo lo si vuol chiamare, è l’indifferenza della legge naturale alle esigenze umane (e non dunque derivazione dall’assurdo); ma non per questo l’essere è nihil, ché anzi tutta la filosofia greca obbedisce al divieto sul non essere imposto da Parmenide (motivo per il quale, dice Jankélévitch, i greci glissano sul problema della morte). La considerazione che la creatura è nihil è una considerazione cristiana che non può venire al cristianesimo dalla grecità. Il tragico greco è la consapevolezza che vi è un destino ineluttabile, non modificabile dall’agire umano, per cui la natura è un ciclo di nascite e morti che sovrasta l’uomo. Tragico è l’inesorabilità della legge di nascita e morte; ma la morte è impensabile e dunque pensabile è soltanto l’essere. Se con Eraclito la legge della natura viene sottratta all’arbitrarietà delle forze, con Parmenide si iscrive tutto il ciclo naturale nella pensabilità dell’essere. Il tragico greco è sempre concepito nel quadro dell’immanenza, sotto il divieto del nulla. Il ciclo della natura non ha un senso umano: è per questo che Socrate non vuole occuparsene; ciò vuol dire che per i greci esso non ha valore? Che lo abbia o no, vi si è inseriti e non è possibile sottrarsene.
A.C. Condivido questa ricostruzione del pensiero greco e del suo strutturale non-nichilismo. Evidentemente sarò stato in qualche passaggio poco chiaro. Provo adesso dunque a delucidare ciò che penso: i Greci hanno un senso schiacciante del destino, talmente forte da neutralizzare la ‘scoperta’ (o l’invenzione) della libertà individuale tipica del cristianesimo. La filosofia moderna oscilla continuamente fra l’eredità greca (pensiamo a Spinoza, Nietzsche o Heidegger) e l’enfatizzazione sino al parossisimo del libero arbitrio soggettivo (pensiamo a Fichte o Sartre). La filosofia prevalente fra i mafiosi mi pare sia più un neo-stoicismo (svuotato della tempra etica originaria) che un riconoscimento coerente dell’autonomia e della responsabilità dell’individuo.
G.P. Ma se la concezione di un Dio «abisso senza fondo» non è di origine greca, perché non dire che deriva proprio dalla elaborazione del concetto di creazione? Non sarebbe più corretto asserire che i mafiosi hanno la concezione cattolica di un Dio che toglie ogni vitalità alla natura perché la considera nulla (giacché in suo potere)? Oltretutto la concezione di un Dio incondizionatamente potente è stata teorizzata in modo esplicito da Giovanni Duns Scoto che ha parlato di potentia absoluta Dei come azione divina straordinaria supra et extra legem, mentre il mondo creato è assolutamente contingente. Gilson ha dimostrato come questa concezione fosse trasmigrata in Descartes, altro autore cristiano. Che il passaggio storico e teoretico fondamentale sia nella rielaborazione moderna post-tridentina della teologia? Un periodo, peraltro, in cui la storia della Sicilia è dominata politicamente dalla chiesa: dai viceré spagnoli (per lo più arcivescovi) al ruolo, ben più pervasivo, delle congregazioni religiose assai diffuse sul territorio. Per questo penso che la visione lugubre mafio-cattolica (per cui dici con efficacia che «il nero, appena striato di grigio, è il colore dominante di questo scenario senza spiragli di luce né sull’oggi né, ancor meno, sul futuro»), sia la stessa delle Leçon de Ténèbres di François Couperin , espressa magnificamente nei marmi dai colori terrei della Chiesa di Gesù a Casa Professa di Palermo!
A.C. Sono d’accordo con quasi tutto ciò che sostieni e, in un’eventuale seconda edizione, cercherò di essere più preciso. Devo ribadire, però, che per me non vanno distinte solo la visione greca e la visione biblica, ma anche la visione biblica dalla visione cattolica. Dunque nelle dichiarazioni dei mafiosi si mischiano elementi greci, elementi biblici ed elementi cattolici (i quali ultimi sono spesso, già, una prima miscela di filosofia greca e di testi ebraico-cristiani).
G.P. Ma c’è ancora qualche altra contestazione che desidero sollevarti. Per liberare il cattolicesimo dalla responsabilità del ‘nulla’, tu la attribuisci all’ateismo. Che dei mafiosi possano essere atei non stupisce (il caso di Matteo Messina Denaro, di cui parli): ma che la loro concezione di Dio – mutuata da quella cattolica – nasconda, dietro il politeismo del culto dei santi, una forma di ateismo implicherebbe in primo luogo un chiarimento su cosa si intenda per ateismo: dire che ateismo è porre come principio l’Assurdo – affermazione che hai ripreso poco fa – è considerarlo come una religione, in quanto esso stabilirebbe comunque una dipendenza, sia pure da un principio assurdo, e questo è contraddittorio, un ateismo che non è ateismo. Mi pare invece che il senso dell’ateismo sia la negazione dell’idea stessa di un principio da cui derivi l’essere. Se è così, esso ha poco a che fare con la religione dei mafiosi … Del resto, l’ateismo moderno di Feuerbach e Marx lo tratti davvero male, perché esso non è soltanto affermazione che Dio è lo strumento delle classi dominanti sulle classi dominate. Se Feuerbach ha detto che “Dio è l’ottativo del cuore umano”, significa che in Dio sono riposte tutte le speranze; e certo il cuore umano fa male a porre in Dio tutte le speranze, se esse sono nella possibilità di soluzione umana; tanto più che di questo Dio indicibile e inafferrabile c’è sempre qualcuno che se ne fa rappresentante, e perciò Marx denuncia la strumentalizzazione che ne fanno le classi dominanti; queste, tuttavia, non riuscirebbero se Dio non fosse la proiezione di chi, sfruttato, non riesce a credere nelle proprie possibilità di salvezza. Quest’ateismo dice proprio che, se possibilità di salvezza o di perdizione c’è, esse sono nelle mani degli uomini stessi. Sono gli uomini responsabili della loro capacità di nientificazione. Per queste ragioni mi sembra che il procedimento adottato nel libro sia un modo di togliere responsabilità culturale al cristianesimo: in fondo non è il cristianesimo responsabile della teologia mafiosa, perché questa è atea! Un modo consolatorio e autoassolutorio.
A.C. Inizio subito, se ho dato l’impressione – che hai registrato – di aver trattato male l’ateismo moderno, col farne ammenda. Penso che un ateo serio e un credente serio siano molto più vicini fra loro di quanto un credente serio non lo sia rispetto ad un credente di bocca buona che ingoia qualsiasi intruglio teologico. Ciò precisato, mi sembra un po’ ingiusto da parte tua arrivare a capovolgere l’accusa, che mi è venuta da alcuni recensori, di avere scritto questo libro per combattere non la mafia, ma la chiesa cattolica! La verità è che la sostanza della mia analisi, al di là di passaggi equivoci o poco chiari, consiste nell’affermare che la cultura cattolica è corresponsabile della formazione della mentalità mafiosa: ‘co-responsabile’ significa che non è né l’unica né la più rilevante delle matrici generatrici.
G.P. Adesso veniamo all’immagine di Dio che tu proponi in alternativa al Dio dei mafiosi: un Dio inafferrabile, «Principio universale del cosmo e della storia», potente e debole allo stesso tempo, trascendente ed immanente. Tuttavia, non si può negare «la sporgenza di Dio rispetto alla totalità degli enti». È un Dio da cui si dipende? Se lo è, quale la differenza dal Dio dei mafiosi? Se non lo è, qual è il senso di questa sporgenza?
A.C. Ci sono molte forme di ‘dipendenza’ e non tutte dicono sottomissione, passività. Io ‘dipendo’ da mille cose: alcune (per esempio i soldi) mi condizionano, ma altre (per esempio le opere letterarie o le belle donne) mi arricchiscono e non sarei altrettanto felice di liberarmene. Il sole, l’aria, il mare: non sono principi vitali basilari per la nostra biologia? Eppure il rapporto con essi, lungi dall’asservirci, ci sostiene.
G.P. Impotente rispetto al male e al destino umano, questo Dio ama l’uomo. Però non è chiaro dal tuo testo in che modo lo ami: ci si preoccupa più di assolverlo dal male (non è responsabile del male che si fanno gli uomini né degli accadimenti naturali come le malattie; inoltre non è un Dio che condanni all’inferno) che di metterne in evidenza l’azione positiva. Si pone il problema del significato dell’amore di Dio dopo le brutture del XX secolo. Forse l’amore di Dio non è altro che la condivisione umana: in questo senso Dio libera attraverso Cristo che insegna la solidarietà e il servizio, nel rispetto delle differenze sessuali, con una spiritualità “incarnata, conviviale, anche sovversiva, gioiosa e non violenta”. Però, se gli uomini per comprendere che è necessaria la solidarietà hanno bisogno di credere in un Dio, significa che c’è una deroga alla loro uscita di minorità: è necessario Dio per assumersi la responsabilità dell’esistere insieme? In che modo Dio non è una figura deresponsabilizzante? Questo Dio non più definito della teologia critica può indicare uno spazio di apertura, un provenire dell’essere e un andare verso. Ma la sua indefinitezza si presta alle strumentalizzazioni: è un sentimento che non può evitare i fondamentalismi. Perché necessariamente è un dio che non parla: un presupposto che è il nulla del pensiero che spinge il pensiero a pensarlo in una impossibilità che corre i rischi denunciati da Hegel a proposito della coscienza infelice.
A.C. Il silenzio dell’agnostico e il silenzio del mistico si somigliano terribilmente. Per me il semantema Dio rimanda a qualcosa di così straordinario, unico, da diffidare ogni volta che qualcuno mi dice di aver capito che esiste o che non esiste. E’ la ragione per cui, quando mi si chiede se credo in Dio, resto paralizzato: se dico sì, temo di essere arruolato in una squadra di gente sempliciotta che crede in un Dio a sua immagine e somiglianza; se dico no, temo di essere considerato un minus habens rispetto al papa o al rabbino capo di Gerusalemme o all’imam capo di Teheran (laddove, invece, ho la presunzione di non dichiararmi ‘monoteista’ per eccesso di fede nel vero Dio, che so che non conoscerò mai, almeno su questa terra). Ma tu non mi chiedi se credo in quella X che gli indoeuropei chiamiamo “Dio”: sei ancora più spiazzante. Mi chiedi conto della tesi (che per la verità non riconosco come mia) che sia necessario credere in Dio per diventare responsabili e maturi. In proposito non ho dubbi: qualsiasi cosa intendiamo tu ed io quando pronunciamo il bisillabo ‘Dio’, la fede in questo “qualsiasi cosa” può tanto aiutarci quanto ostacolarci nella nostra crescita umana. Vedi, allora, perché mi riesce difficile rispondere alla tua domanda? La storia lo attesta senza ombre: non è necessario credere in ‘Dio’ per comportarsi come Gandhi, Luther King o Che Guevara. Ciò chiarito, non vorrei sottrarmi ad una terza questione che fa capolino fra le tue righe: che ‘funzione’ ha Gesù per un cristiano? Ti rispondo da teologo che si autodefinisce “oltrecristiano”: il Messia, come altre personalità religiose, ha squarciato questo silenzio ipertenebroso non tanto “insegnando” a vivere diversamente ma testimoniandolo. Ha, in qualche misura, reso presente e operante nel mondo l’invisibile, enigmatico Amore divino. La sua esperienza è paradigmatica, non esclusiva: ogni donna e ogni uomo ci realizziamo facendoci “sacramenti” dell’Inafferrabile. Io posso diventare un suonatore o un cantante meraviglioso e allietare le lunghe sere del mio villaggio intorno al falò anche senza sapere che Bach o Mozart o la Callas siano esistiti: ma se l’attitudine naturale è stata coltivata alla scuola di Bach, di Mozart o della Callas, ho una marcia in più.
| Augusto Cavadi |
| Il Dio dei mafiosi |
| Edizioni San Paolo |
| Milano 2009 |
| Pagine 143 |
Nessun commento