Briciole di libertà nella Recherche
Passato, presente, libertà
Quanto influisce il passato sul presente? Saremmo tentati di rispondere in modo totale. Soprattutto se si considera la questione da un punto di vista antropologico, la misura in cui cioè il tempo che siamo stati determina l’attualità del nostro vivere. Troppo difficile sarebbe anche solo tentare di individuarne le dirette conseguenze ed è infatti da un’altra angolatura che vorrei guardare alla cosa. Non tanto alla qualità del passato, dolorosa, gioiosa o funesta che sia, bensì alla sua quantità. Mi riferisco al numero di anni che ci prolungano sul presente, la scia di ricordi che ci segue quando camminiamo, la vertigine paurosa della vecchiaia. Anche il semplice fatto di aver vissuto tempo su tempo e di averlo con noi, nella capigliatura che inizia a diradarsi, nelle forze che vengono meno e soprattutto nei dolori che rovinosamente ci conducono alla morte. Sembra però che più il passato aumenta e la storia si fa carne in noi, più una sensazione di costrizione ci coglie, come se il quantitativo di possibilità che la vita può ancora darci si affievolisca, rendendola dunque qualcosa di segnato.
Nella Zeitlichkeit costitutiva dell’umano, per esprimerci con il sempre valido gergo heideggeriano, alla fluidità del possibile subentra la fissità del già stato e dell’immodificabile, che è tale proprio per via dell’accumulazione storica. La vita umana, la nostra esistenza temporale sulla quale la condanna dell’ora che avanza indurisce la fibra del vivere, è necessità diveniente. Ma è davvero così? È la sua essenza, traducendo la questione in altri termini, libertà che diminuisce o creazione del monolite temporale che chiamiamo appunto passato? Sia chiaro, comunque, che a questo livello il fatto che la memoria sia plastica e che i ricordi possano mutare è importante sotto il profilo epistemologico ma irrilevante sotto quello ontologico. Come si struttura allora la relazione tra il tempo che è stato e quello presente? Qual è il rapporto tra passato e libertà? Resiste ancora nel nostro tempo che si è fatto storia un certo margine di libertà?
Negli strani e sofferti percorsi del vivere, e negli innumerevoli tentativi che noi facciamo per attribuire loro un senso, direi che esistono delle briciole lasciate in modo spesso inconsapevole, che segnano il cammino e che rappresentano l’orientamento nella storia delle libertà che possiamo ancora ottenere, ritrovando mondi e gioie che altrimenti avremmo creduto interamente perduti. Il passato reca con sé la facoltà dell’essere liberi che si protende nel presente e che su di esso può fare ritorno. Nel piramidarsi degli anni che si pongono gli uni sugli altri rastremando sempre più le linee direttrici convergendo verso il vertice, la morte, ciò che non è stato ma che poteva realizzarsi è ancora investito dell’aura del possibile, e quindi del realizzabile.
Un luogo comune della riflessione filosofica intende il passato come necessitato (il destino) e il futuro come possibile (il non ancora realizzato). Gli atti intellettuali rivolti al primo e al secondo sono rispettivamente la comprensione e la previsione. Posso tentare di capire come e cosa nel passato è accaduto senza però avere la facoltà di cambiarlo, e immaginare lo svolgimento possibile di eventi non ancora accaduti. Comprendere il passato, tuttavia, costituisce già una forma di predizione: cogliere le dinamiche di ciò che è stato e avere una rivelazione o anche l’intendimento di qualcosa che era rimasto oscuro muta profondamente la vita. In questa prospettiva il tempo, dal punto di vista del passato, è necessità che si compie sedimentandosi nell’immutabile; dal punto di vista del futuro, è possibilità che diminuisce con il crescere del passato stesso. Come intendere allora il presente? È possibile concepire un rapporto tra passato e futuro in cui intervenga un concetto metafisico terzo rispetto a necessità e possibilità? Credo che tale dispositivo antropologico-temporale sia proprio la libertà. La libertà che modifica il tempo che si necessita nel passato e che prevede, nel margine che il presente gli garantisce, il futuro. Se così non fosse, infatti, se non intervenisse nessuna forza a modificare il flusso, passato e futuro, ovvero il tempo umano in generale, sarebbero necessitati senza alcuna possibilità di modificazione. Il tempo sarebbe allora un farsi passato su cui il futuro non può più alcunché. La storia della nostra vita diverrebbe pura necessità. Non saremmo più, ed è questo il mio punto, liberi al nostro passato. Saremmo, anzi, dominati dal passato, inghiottiti da esso, posseduti.
Kierkegaard
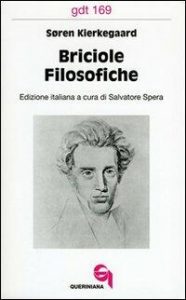 Cosa tentare allora per sciogliere il problema? Questa breve premessa mi consente di proporre un’altra argomentazione. Per far ciò mi avvalgo di due figure filosoficamente eminenti, pensatori che hanno offerto da una parte una struttura concettuale e dall’altra la vita in cui poterla impiantare. E mi riferisco a una coppia forse contradditoria ma per i nostri fini assai utile, e cioè Søren Kierkegaard e Marcel Proust.
Cosa tentare allora per sciogliere il problema? Questa breve premessa mi consente di proporre un’altra argomentazione. Per far ciò mi avvalgo di due figure filosoficamente eminenti, pensatori che hanno offerto da una parte una struttura concettuale e dall’altra la vita in cui poterla impiantare. E mi riferisco a una coppia forse contradditoria ma per i nostri fini assai utile, e cioè Søren Kierkegaard e Marcel Proust.
Il pensatore danese, con un brano tratto dall’Interludio delle Briciole filosofiche, intitolato in un modo per noi eloquente Il passato è più necessario del futuro?, si pone appunto il problema della necessità del passato e della possibilità del futuro, nonché, come trait d’union, delle condizioni di realizzabilità della libertà. È infatti in questi termini che pone il problema: «Se in un solo punto la necessità potesse entrare, non si potrebbe più parlare né di passato né di futuro. Voler prevedere il futuro (profetare) e voler capire la necessità del passato è esattamente la stessa cosa e soltanto la moda fa sembrare l’una o l’altra più o meno plausibile a una generazione. Dunque, il passato è accaduto: il divenire è la mutazione della realtà mediante la libertà. Se, ora, il passato fosse divenuto necessario, non apparterrebbe più alla libertà, cioè a ciò per cui è divenuto. La libertà si troverebbe in una penosa situazione, non si saprebbe se ridere o piangere, perché sarebbe responsabile di ciò che non le appartiene, di aver prodotto ciò che ingoierebbe la necessità. La libertà stessa sarebbe un’illusione e il divenire anche; la libertà sarebbe un sortilegio e il divenire un falso allarme»1. Il punto di Kierkegaard è questo: se il tempo è il divenire che si fa passato diventando necessità e se su tale dimensione non si può più intervenire in alcun modo, ogni istanza di salvare con la libertà il tempo dalla necessità stessa perde di fondamento. La libertà è ciò che rende possibile il non ancora necessitato. La questione si sottilizza ancora: se il passato fosse necessario, anche ciò per cui è divenuto tale, cioè la libertà, diverrebbe necessità, sicché la libertà in toto si ridurrebbe a mera illusione della ragione. Per salvare il passato dalla necessità, deve esistere in ciò che è ritenuto immodificabile un germe di libertà che possa richiamarlo almeno a una triplice radice: la comprensione, l’azione e la trasformazione.
Se il momento della modificabilità è rimesso alla libertà, il passo immediatamente successivo consiste nel rinvenire nel passato momenti di libertà inespressa e scatenati dal presente. Per Kierkegaard tale momento della libertà ha diverse componenti, le cui principali, nel suo impianto teologico, sono per lo più decisione e conversione. La libertà verso il passato è la possibilità di allontanarsi da esso, cambiare se stessi sulla base della sua comprensione, accogliere il mutamento nella vita e così trasformarla. Nella relazione maestro-allievo discussa da Kierkegaard, con il successivo affaccio nel Cristo, il filosofo fornisce infatti una definizione assai preziosa di momento, che ci consente di prolungare la riflessione sul secondo pensatore chiamato in causa. È in questo modo che Kierkegaard concettualizza il momento in relazione alla consapevolezza sull’errore esistenziale di sé: «È, intanto, breve e temporale come è il momento, transeunte come il momento, passato come è il momento nel momento successivo, eppure è decisivo e pieno di eternità. Questo momento deve avere un nome particolare, chiamiamolo: la pienezza del tempo»2. Non si tratta quindi, nonostante sia uguale nella forma, di un momento temporale tra gli altri, se vogliamo la zona liminare tra passato e futuro che si compie nel presente e in cui è doveroso rintracciare filosoficamente la radice della libertà o della necessità. È il momento della pienezza, in cui l’eternità entra nel tempo. Di quale eternità si tratta? Per Kierkegaard, è facile, di Dio. E tuttavia, com’è possibile che l’irruzione dell’eternità nel momento della pienezza temporale riesca a rendere sostenibile la libertà, a sprigionare il passato e così progettare diversamente il futuro? Come fa l’azione assolutamente condizionante dell’eternità a liberare il passato?
Proust
 È allora in questa tensione tra tempo ed eternità che si colloca Proust, il quale ha inteso il momento dei momenti, quello della memoria involontaria, il luogo della transizione, lo stigma della pienezza. Il fatto di ricordare attraverso un evento del tutto casuale, e quindi anche privo di necessità, significa prelevare una parte del passato esistenziale dall’oblio e porlo nell’eternità del senza tempo, in una dimensione piena poiché non è né passata né futura, ma tempo puro che non scorre e a cui corrisponde un’essenza incorruttibile fuori dal divenire. Assaporare l’eterno è scatenarsi dalle pastoie del divenire e dal rincorrersi di momenti inanellati da forze più grandi del nostro potere, è una libertà temporale che modifica il vissuto, cambia il passato, converte la vita. Il momento che modifica il passato necessitato, nella pienezza del tempo che assale di luce il Narratore, è il momento della liberazione, con la quale giungere, infine, alla libertà vera e propria. La libertà di disporre del tempo futuro intervenendo sul passato cambiandolo, trasfigurandolo e, nella grandiosità proustiana, scrivendolo ad arte in un’opera chiamata À la recherche du temps perdu.
È allora in questa tensione tra tempo ed eternità che si colloca Proust, il quale ha inteso il momento dei momenti, quello della memoria involontaria, il luogo della transizione, lo stigma della pienezza. Il fatto di ricordare attraverso un evento del tutto casuale, e quindi anche privo di necessità, significa prelevare una parte del passato esistenziale dall’oblio e porlo nell’eternità del senza tempo, in una dimensione piena poiché non è né passata né futura, ma tempo puro che non scorre e a cui corrisponde un’essenza incorruttibile fuori dal divenire. Assaporare l’eterno è scatenarsi dalle pastoie del divenire e dal rincorrersi di momenti inanellati da forze più grandi del nostro potere, è una libertà temporale che modifica il vissuto, cambia il passato, converte la vita. Il momento che modifica il passato necessitato, nella pienezza del tempo che assale di luce il Narratore, è il momento della liberazione, con la quale giungere, infine, alla libertà vera e propria. La libertà di disporre del tempo futuro intervenendo sul passato cambiandolo, trasfigurandolo e, nella grandiosità proustiana, scrivendolo ad arte in un’opera chiamata À la recherche du temps perdu.
Leggendo Kierkegaard alla lettera emerge chiaramente che il momento è quello della fede, cioè Dio che irrompe nella vita dell’individuo allo stesso modo in Proust della maestà del cosmo, che nella sua epifania materico-temporale rivela se stesso nella percezione di un uomo che ricorda il suo oblio e comprende l’identità tra il divenire e la materia. Nondimeno, l’analogia concettuale con il pensatore danese resta in piedi. Provare l’eterno dentro di sé induce alla consapevolezza dolorosa dell’errore che è nota come pentimento: «Cos’altro, infatti, è il pentimento che si guarda indietro, ma in modo tale che proprio per questo affretta il passo verso ciò che gli sta innanzi?»3. Ma transitare dall’errore al rinsavimento, riscattare il dolore in gioia, vuol dire passare dal non-essere all’essere: «Colui che esiste non può essere generato; egli, invece, è generato. Chiamiamo questo passaggio rinascita con la quale egli viene al mondo un’altra volta»4. Scatenarsi dalla necessità di un passato doloroso e motivo di soffocamento continuo è la liberazione che il Narratore proustiano ci racconta a proposito del suo momento eccezionale, a cui segue la radicale riconsiderazione del vissuto in vista di una sua riappropriazione.
La liberazione, per così dire, non basta, bisogna poi decidersi per essa, e proprio in ciò sta la radice della libertà per il passato che cercavamo. In un modo per me limpido, Kierkegaard spiega l’azione imminente del Narratore: «Ma se è nell’errore egli deve pensare ciò da se stesso, e il ricordo non è in grado di aiutare a pensare ciò. Se deve andare oltre, è il momento che deve deciderlo (anche se questo lo ha già messo in grado di capire che era nell’errore)»5. Il Narratore è richiamato a scegliere il momento in quanto decisione che accoglie il tempo che la libertà gli prospetta, il passato aperto nuovamente al possibile e che adesso, munito di tale comprensione, può essere cambiato, può farsi libero sia per se stesso che per il mondo. «Nel momento l’uomo prende coscienza di essere nato, perché il suo stato precedente, al quale non può riferirsi, era proprio quello di non essere. Nel momento egli prende coscienza della sua rinascita perché il suo stato precedente era appunto di non essere. Se il suo stato precedente fosse stato di essere, allora in nessuno dei casi il momento avrebbe avuto un’importanza decisiva per lui»6. In cosa rinasce però il Narratore? E in quale forme si concretizza la libertà di poter disporre della possibilità da far agire nel passato della sua esistenza marcita tra dolore e noia?
Tentando di riassumere il racconto che fa il Narratore della sua vicenda, egli è immerso nel peccato più grave che Proust a mio giudizio potesse mai concepire, ovvero il tempo perduto come tempo esistenziale non riscattato dall’arte. Il passato lo ha legato a forza, inibendo ogni possibilità autentica. Inoltre, Parigi è colpita dalla guerra, gli amici di un tempo o sono morti oppure sopravvivono mestamente tratteggiando la più grottesca delle caricature di se stessi, sono avvenute le più impensabili delle acrobazie sociali e, soprattutto, la vita per il Narratore è divenuta una presenza di nauseabonda inutilità. È questo stato d’animo che lo induce a recarsi all’ennesimo ricevimento in casa della principessa di Guermantes. Ed è lì che accadono il momento, il pentimento, la conversione e la rinascita, oppure, con un paio concettuale ancora più efficace, la liberazione e l’esercizio della libertà. «Mais c’est quelquefois au moment où tout nous semble perdu que l’avertissement arrive qui peut nous sauver, on a frappé à toutes les portes qui ne donnent sur rien, et la seule par où on peut entrer et qu’on aurait cherchée en vain pendant cent ans, on y heurte sans le savoir, et elle s’ouvre»7.
Gli strali della memoria involontaria posti da Proust l’uno di seguito all’altro in modo irresistibile costituiscono i momenti dell’eternità e della liberazione dai ceppi di una vita corrosa dal male, a partire dai quali il Narratore concepisce quel cambio di prospettiva sul passato che glielo farà conoscere sotto la luce della libertà. Ma libertà di compiere cosa? Ciò che credeva essere accaduto una volta per tutte, e per di più dimenticato, può essere trasfigurato e redento nella forma dell’arte, una magia fatta di parole e concetti che nella musica delle sillabe restituisce il divenire di una singolarità esistenziale, quella appunto del Narratore, che non solo può intendere se stesso sub specie aeternitatis ma compiere in un’opera la trasformazione totale di sé, mutare il passato in forma, il vissuto in parola, il peccato in luce.
Se Kierkegaard aveva spiegato, con una formula magnifica e tale da meritare di essere ricordata, che «il divenire è la mutazione della realtà mediante la libertà», e se con «realtà» può intendersi il passato divenuto necessità essendosi fissato nella storia e nella parvenza immutabile che alla storia appartiene, Proust invece mostra come fare del passato un nuovo principio di mutazione, che è anzitutto certamente ontologica (il divenire che muta ciò che era in forme inedite), ma anche individuale e antropologica, cambiare alla radice il passato che è stato attribuendo nuove opportunità di senso, e direi purificandolo e innalzandolo alla dignità luminosa dell’arte e della parola letteraria. «La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie, par conséquent pleinement vécue, c’est la littérature. Cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant chez tous les hommes aussi bien que chez l’artiste. Mais ils ne la voient pas, parce qu’ils ne cherchent pas à l’éclaircir»8. In qualche modo, aggiunge Proust, non si è del tutto liberi di fronte all’opera d’arte, poiché essa si è accresciuta dentro di noi senza che ne fossimo consapevoli. Il compito dello scrittore sta soltanto nel tradurre ciò che ora si è risvegliato in letteratura. Ma questa libertà ritrovata non è per nulla una nuova manifestazione della costrizione a cui ci riporta un passato non saputo, bensì, ancora una volta, un potentissimo principio di cambiamento esistenziale che ci rimette autenticamente a noi stessi.
La Recherche è leggibile infatti come la storia della libera appropriazione compiuta da Proust di sé e del suo passato, resa possibile dalla conoscenza dell’eterno e dal dispositivo tanto caro allo scrittore della memoria involontaria. Parlo di un passato che può sprigionarsi nella libertà di diventare un’opera scritta. L’essenza della libertà proustiana può essere definita come la possibilità di disporre del proprio passato ricordato e venuto alla luce della parola sublimandolo in opera letteraria. È chiaro allora come il passato raccontato dal Narratore non sia quello di Proust, una mera autobiografia che non sarebbe servita a nulla, e come lo scrittore, spiegandocelo con la mise en abyme continua che è la Recherche, abbia disposto della sua storia altrimenti immodificabile e stantia per farne altro, per realizzare uno strumento di comprensione e di salvezza.
Liber libertatum
 Ma questo vorrebbe forse dire che sono l’immaginazione e la fantasia del grande scrittore che ci rendono liberi? Che coloro i quali non sono provvisti del genio irripetibile di Proust sono condannati alla schiavitù dell’ignoranza? Che un’opera letteraria, qualunque essa sia, purché costituita sulla fantasia biografica dell’autore, significa per ciò stesso libertà? Credo che le cose stiano diversamente. Il libro proustiano è un’opera sacra che se capita fino in fondo intercetta la vibrazione di verità del mondo. Il peso del passato e la costrizione di cui parlavo all’inizio si dissolvono non appena si comprende che tale passato può essere, utilizzando non a caso una parola del lessico carcerario, riformato. Liberarsi dal passato, essere liberi nei suoi confronti, vuol dire capire ciò che vi restava di oscuro, tagliare i legacci che ci tenevano ancora avvinti al mondo, raccontare anche ciò che del passato, per i casi avversi e dolorosi che si oppongono ai nostri desideri, non avviene e resta involuto in se stesso.
Ma questo vorrebbe forse dire che sono l’immaginazione e la fantasia del grande scrittore che ci rendono liberi? Che coloro i quali non sono provvisti del genio irripetibile di Proust sono condannati alla schiavitù dell’ignoranza? Che un’opera letteraria, qualunque essa sia, purché costituita sulla fantasia biografica dell’autore, significa per ciò stesso libertà? Credo che le cose stiano diversamente. Il libro proustiano è un’opera sacra che se capita fino in fondo intercetta la vibrazione di verità del mondo. Il peso del passato e la costrizione di cui parlavo all’inizio si dissolvono non appena si comprende che tale passato può essere, utilizzando non a caso una parola del lessico carcerario, riformato. Liberarsi dal passato, essere liberi nei suoi confronti, vuol dire capire ciò che vi restava di oscuro, tagliare i legacci che ci tenevano ancora avvinti al mondo, raccontare anche ciò che del passato, per i casi avversi e dolorosi che si oppongono ai nostri desideri, non avviene e resta involuto in se stesso.
La Recherche, questo liber libertatum, rappresenta anche una ciclica delle liberazioni, poiché avendo redento il passato peccaminoso incoraggia lo scrittore a scrivere e il lettore a capire ciò che senza lo scrittore non avrebbe mai potuto cogliere di sé, trattandosi in prima istanza di una liberazione dal passato negletto emendabile con l’arte e con l’espiazione che la lettura della Recherche, se saputa leggere, garantisce, e infine di una liberazione persino dalla vita stessa, forse il concetto generale di libertà più grande che esista, quando il pensiero della morte da avverso diventa favorevole, e si vede in lei l’amante capace di concederci quell’amore che nessuna in forma di donna è stata in grado di accordarci. Quella morte che vince il patire e solleva dal dolore che la vita è in sé, sempre:
Mais tout de même, quand un être est si mal conformé (et peut-être dans la nature cet être est-il l’homme) qu’il ne puisse aimer sans souffrir, et qu’il faille souffrir pour apprendre des vérités, la vie d’un tel être finit par être bien lassante. Les années heureuses sont les années perdues, on attend une souffrance pour travailler. L’idée de la souffrance préalable s’associe à l’idée du travail, on a peur de chaque nouvelle œuvre en pensant aux douleurs qu’il faudra sopporter d’abord pour l’imaginer. Et comme on comprend que la souffrance est la meilleure chose que l’on puisse rencontrer dans la vie, on pense sans effroi, presque comme à une délivrance, à la mort9.
Riscattare il passato è un esercizio di libertà, un dono del sapere e della filosofia. Dal punto di vista dell’individuo la voce di Proust dà aiuto, fa gustare davvero dei momenti di libertà. Resto però con un altro interrogativo, se cioè tale dinamica, ancorché intravista nella possibile universalità della sua applicazione considerando una platea di innumerevoli lettori, abbia una presa anche sulla collettività umana tutta, in ciò che anche Kierkegaard chiamava non più passato individuale ma storia. Eppure, se di storia in quanto passato della vicenda umana a questo mondo dobbiamo parlare, della possibilità di redenzione che in essa è doveroso costruire, non è con Søren Kierkegaard che possiamo sperare di illuminare Proust, bensì, auspicando un’altra riflessione, con Walter Benjamin.
Note
1 S. Kierkegaard, Briciole filosofiche (Philosophiske Smuler, 1844), trad. di S. Spera, Queriniana, Roma 2012, pp. 140-141.
2 Ivi, p. 70.
3 Ivi, p. 71.
4 Ibidem.
5 Ivi, p. 73.
6 Ibidem.
7 M. Proust, Le Temps retrouvé, in À la recherche du temps perdu, a cura di J.-Y. Tadié, Parigi, Gallimard, 2019, p. 2262. «Ma, a volte, proprio quando tutto ci sembra perduto, ecco il segnale che ci può salvare. Abbiamo bussato a porte che si affacciavano tutte sul nulla, ed ecco che, ora, ci imbattiamo inavvertitamente nell’unica attrazione verso la quale è possibile entrare, e che avremmo cercato invano per cent’anni, ed essa si apre», trad. di M.T. Nessi Somaini, Rizzoli, Milano 2012, p. 243.
8 Ivi, pp. 2284-2285. «La vera vita, la vita finalmente scoperta e messa in luce, di conseguenza la sola vita realmente vissuta è la letteratura, vita che, in un certo senso, dimora in ogni momento in tutti gli uomini così come nell’artista. Ma essi non la vedono perché non cercano di portarla alla luce», trad. p. 280.
9 Ivi, p. 2295. «Ma, comunque sia, quando un essere è così malconformato (e forse in natura quest’essere è proprio l’uomo) da non poter amare senza soffrire, e di aver bisogno di soffrire per apprendere certe verità, la vita di un tale essere finisce per diventare davvero stressante. Gli anni felici sono anni perduti, si aspetta una nuova sofferenza per poter lavorare. L’idea della sofferenza preliminare si associa all’idea di lavoro, si teme ogni nuova opera pensando ai dolori che prima si dovranno sopportare per poterla concepire. E non appena si capisce che la miglior cosa che si possa incontrare nella vita è la sofferenza, si pensa senza paura, quasi come a una liberazione, alla morte», trad. p. 297.
Nessun commento