Un capitolo dilemmatico dell’africanismo: la Poornography
 Ci sono momenti e fasi, nella storia della cultura, in cui la ricerca dell’originalità può risultare stucchevole, o proterva, o finanche ingiuriosa. Fasi in cui l’ascolto è l’atteggiamento più sano: sia sotto il profilo della comprensione, che, insieme e inscindibilmente, sotto quello etico e politico. L’Europa ha già conosciuto una straordinaria epoca di ascolto, il Rinascimento, quando le voci dell’antico – che in verità non si erano mai perse del tutto– ritornarono in maniera potente, fluviale, pervasiva e, oggi lo sappiamo, conducendo con sé un senso tragico dell’esistenza ben lontano da ogni classicismo pacificato e aulico (e questo senso tragico riportarono nei paesaggi di pensabilità che furono chiamati a dipingere per dar ragione dell’età moderna). Certo, in quel caso si trattò di riconoscere antenati e padri, di rinnovarsi alle fonti antiche del Medesimo – è sufficiente pensare alla storia urbanistica di Roma fra Quattro e Cinquecento per capire quanti pontefici di cultura raffinatissima fossero poco disposti a resistere al fascino del pagano; mentre poco più a nord, la strategia filosofica di Marsilio Ficino si provava a legittimare la continuità teorica tra ragione pagana e pensiero cristiano.
Ci sono momenti e fasi, nella storia della cultura, in cui la ricerca dell’originalità può risultare stucchevole, o proterva, o finanche ingiuriosa. Fasi in cui l’ascolto è l’atteggiamento più sano: sia sotto il profilo della comprensione, che, insieme e inscindibilmente, sotto quello etico e politico. L’Europa ha già conosciuto una straordinaria epoca di ascolto, il Rinascimento, quando le voci dell’antico – che in verità non si erano mai perse del tutto– ritornarono in maniera potente, fluviale, pervasiva e, oggi lo sappiamo, conducendo con sé un senso tragico dell’esistenza ben lontano da ogni classicismo pacificato e aulico (e questo senso tragico riportarono nei paesaggi di pensabilità che furono chiamati a dipingere per dar ragione dell’età moderna). Certo, in quel caso si trattò di riconoscere antenati e padri, di rinnovarsi alle fonti antiche del Medesimo – è sufficiente pensare alla storia urbanistica di Roma fra Quattro e Cinquecento per capire quanti pontefici di cultura raffinatissima fossero poco disposti a resistere al fascino del pagano; mentre poco più a nord, la strategia filosofica di Marsilio Ficino si provava a legittimare la continuità teorica tra ragione pagana e pensiero cristiano.
Oggi, agli inizi di un nuovo millennio, non si tratta più di ascoltare il Medesimo, anzi meglio: solo il Medesimo; ma di ascoltare voci ‘altre’ in una fase in cui il termine ‘tragedia’ investe il cuore di processi storici che hanno mutato, sconvolto e anche distrutto le vite di milioni di uomini. A quei processi si è dato il termine complessivo di ‘colonialismo’, e di ‘decolonizzazione’ alla lunga e ancora aperta fase di fuoriuscita politica, economica e culturale dall’età coloniale; così aperta che talvolta appare ancora da iniziarsi, a fronte di fenomeni che rivelano piuttosto dinamiche opposte, neocoloniali, che impediscono un confronto necessario e autentico con una storia puntellata di crimini collettivi (e che la storiografia ci insegni come da tre secoli di tratta atlantica e da decenni di tratta interna – quest’ultima legata alle grandi trasformazioni ottocentesche nella fase del cosiddetto commercio ‘lecito’ – abbiano tratto profitto pezzi di società africana specializzata nella razzia e nel commercio degli schiavi, non ci rende affatto protagonisti meno colpevoli di una spartizione violenta e disumana).
Logiche neocoloniali che trovano il loro pendant interno nella marea montante di nuove forme (la mia pars storicista non crede che ci possa essere mai nulla di ‘vecchio’ nella storia) di pensiero razzista, e di relativi fenomeni sociali, nell’Europa contemporanea – in uno con l’incapacità statunitense di porre realmente rimedio alla questione del razzismo; e con il corollario insidioso di un linguaggio, nella politica e nella comunicazione di massa, di spaventosa semplificazione, di devastante portata conflittiva, di riduzione del pensiero a parole d’ordine contro, volta a volta, l’ideologia immigrazionista, la cultura filoislamica, il ‘buonismo’. L’armamentario dottrinale del partito della fortezza-Europa è purtroppo noto, ed è completamente escluso che abbia il benché minimo senso approntare un contro-vocabolario che risponda ad un regime di semplificazione opposta – né, mentre il razzismo demolisce senza scrupoli i fondamenti sociali del vivere democratico, può essere la deriva del politically correct, che sterilizza la giustizia delle differenze nella paralisi astiosa delle minoranze armate, la risposta. Piuttosto, si possono cercare di cogliere alcuni recenti segnali positivi di natura politica: le scuse formali del governo tedesco per il genocidio degli herero, il riconoscimento da parte belga della ferocia belluina del Congo di Leopoldo II, la commissione istituita da Macron in Francia per la restituzione delle opere d’arte africane sottratte durante l’occupazione coloniale.
Cosa può dunque fare oggi un intellettuale occidentale (anche quelli provinciali e di provincia, com’è il caso di chi scrive) per contribuire alla decolonizzazione culturale? Una delle risposte potrebbe essere: organizzare all’università corsi sulla filosofia africana contemporanea (lo ammetto, questa è un po’ troppo pro domo mea, però sarebbe davvero utile che nella ancor timida apertura italiana alla filosofia interculturale, oltre ai latinoamericani e al buddhismo, si iniziassero a leggere gli Eboussi Boulaga, gli Hountondji, i Serequeberhan). Un’altra delle risposte possibili, che ha certamente a che vedere con la prima, è ascoltare. Ascoltare le voci degli intellettuali africani – non solo nelle università, ma in circuiti di comunicazione e di divulgazione più ampi. D’altronde non si tratta affatto, quando si parla di ascolto, di una operazione neutrale: proprio i filosofi e gli eruditi del Rinascimento ci hanno insegnato che scegliere da un archivio per selezionare un florilegio di brani o seguire un filone tematico tra le fonti è un’operazione che risponde ad una precisa volontà selettiva. Si tratta solo di esserne il più consapevoli possibile, e di chiarire anzitutto a se stessi i binari su cui quella volontà si muove: in questo caso l’ansia di un giudizio storico adeguato, il salutare richiamo – dopo anni di cosiddetto riflusso – a grandi temi civili per l’impegno intellettuale, la scoperta, anche, di mondi culturali di straordinaria ricchezza e intensità di pensiero. Perciò si può scegliere di partire dalle questioni di vasta portata (la dibattutissima questione dell’identità della filosofia africana, ad esempio); oppure si può scegliere un caso peculiare – e non solo perché lo consiglia il contesto editoriale – e, per scelta di metodo, vedere quanto di istruttivo può rivelare. In effetti, la poornography, e la sua Africa povera, sono un caso comprensibile solo all’interno della versione africana dell’orientalismo (Said), ossia delle dinamiche della invention of Africa (Mudimbe).
La concezione e la pratica della poornography, in Occidente, presuppongono anzitutto e in generale un regime di separatezza fra carità e giustizia, così come, in primo luogo, si è venuto realizzando nelle democrazie moderne, fondate sulla separazione di Chiesa e Stato. La carità, in forma di assistenza umanitaria ispirata al messaggio evangelico, si configura come missione ecclesiale; la giustizia, invece, rimane terreno occupato dalla sovranità statale. Laddove il nesso fra democrazia e giustizia – intesa come giustizia sociale – si indebolisce, come mostra l’arretramento contemporaneo dello stato sociale, lo spazio della carità si espande in forme di supplenza. In secondo luogo, e più di recente, la distinzione fra carità e giustizia è centrale nel capitalismo contemporaneo, nella misura in cui essa marginalizza l’economia del dono e produce uno spazio che risulta marginale nella sostanza del concetto – dal punto di vista della logica del profitto – ma che pure riveste grande rilievo nel confezionamento di un immaginario sociale funzionale e addomesticato. In questo caso, sono la filantropia e i bilanci ‘sociali’ delle imprese e delle banche a costruire l’immagine di una carità laica, quella dei benefattori (do-gooders). In entrambe i casi, comune è l’effetto: la natura sistematica, sotto il profilo delle cause reali e strutturali, delle emergenze di cui la carità e la filantropia si occupano viene occultata; sicché il soccorso non è anche, come dovrebbe essere, una richiesta di cambiamento. Il caso del continente africano è esemplare, in questo senso. Se ne mostrano tutte le tragiche debolezze, mentre si evita di mettere in mostra tutti quegli aspetti che quell’immagine di un’Africa povera, desolata, disperata, potrebbero contraddire; e si occulta ogni ragionamento strutturale sulle cause di quelle emergenze. Anche nel caso africano, la logica filantropica dei benefattori è orientata al soccorso individuale o legata ad una specifica e circoscritta emergenza. Essa chiede soccorso ma non chiede comprensione.
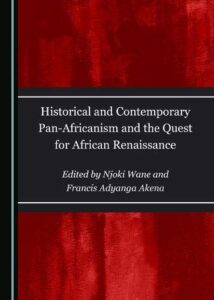 La logica della poornography si muove entro questa cornice di separatezza fra giustizia e carità: mostrare la nudità dei poveri, la nuda povertà, al fine di raccogliere denaro in Occidente. La poornography diventa uno strumento per massimizzare il guadagno, una «compassion usury» per mobilitare la coscienza e il supporto finanziario del pubblico, soprattutto televisivo: le aid agencies richiamano l’attenzione sulla povertà, ma rischiandone una «simplistic moralization» mossa da un «headless heart»[1]. Per poter reggere, il richiamo deve perpetuare il suo incastonamento in un contesto stereotipato e funzionale, quello per il quale «Africans are backward, primitive, unintelligent, dirty, hungry, poor, desperate, violent, and perpetually at war with themselves»[2]. Nella genealogia dei costruttori dello stereotipo dell’Africa e degli africani come privi di storia e di civiltà, preda degli istinti ineducati della natura, il primato consueto spetta a Hegel; ma Raymond Aina ricorda debitamente come anche Thomas Jefferson sostenesse il dogma dell’inferiorità nera, in virtù del quale neri e caucasici risultavano eguali solo nella capacità mnemonica, mentre del raziocinio logico solo ai bianchi si attribuiva la capacità astrattiva, lasciando i neri preda di una immaginazione abnorme, anomala, persino noiosa. Una collezione di stereotipi che la poornography riassume nell’immagine dell’Africa continente della povertà per antonomasia. Per funzionare, lo stereotipo ha bisogno vitale di una povertà dell’informazione: meno informazione è disponibile, più l’opinione pubblica occidentale può confermarsi nell’immagine semplificata dell’Africa povera. Il paradosso della poornography sta qui: nella necessità di alimentare, mantenere e consolidare l’immagine dell’Africa povera ed ‘arretrata’ per potere avere accesso alla beneficenza occidentale e mantenere progetti di sviluppo e i relativi esperti.
La logica della poornography si muove entro questa cornice di separatezza fra giustizia e carità: mostrare la nudità dei poveri, la nuda povertà, al fine di raccogliere denaro in Occidente. La poornography diventa uno strumento per massimizzare il guadagno, una «compassion usury» per mobilitare la coscienza e il supporto finanziario del pubblico, soprattutto televisivo: le aid agencies richiamano l’attenzione sulla povertà, ma rischiandone una «simplistic moralization» mossa da un «headless heart»[1]. Per poter reggere, il richiamo deve perpetuare il suo incastonamento in un contesto stereotipato e funzionale, quello per il quale «Africans are backward, primitive, unintelligent, dirty, hungry, poor, desperate, violent, and perpetually at war with themselves»[2]. Nella genealogia dei costruttori dello stereotipo dell’Africa e degli africani come privi di storia e di civiltà, preda degli istinti ineducati della natura, il primato consueto spetta a Hegel; ma Raymond Aina ricorda debitamente come anche Thomas Jefferson sostenesse il dogma dell’inferiorità nera, in virtù del quale neri e caucasici risultavano eguali solo nella capacità mnemonica, mentre del raziocinio logico solo ai bianchi si attribuiva la capacità astrattiva, lasciando i neri preda di una immaginazione abnorme, anomala, persino noiosa. Una collezione di stereotipi che la poornography riassume nell’immagine dell’Africa continente della povertà per antonomasia. Per funzionare, lo stereotipo ha bisogno vitale di una povertà dell’informazione: meno informazione è disponibile, più l’opinione pubblica occidentale può confermarsi nell’immagine semplificata dell’Africa povera. Il paradosso della poornography sta qui: nella necessità di alimentare, mantenere e consolidare l’immagine dell’Africa povera ed ‘arretrata’ per potere avere accesso alla beneficenza occidentale e mantenere progetti di sviluppo e i relativi esperti.
Alla logica monolitica dello stereotipo non si può che rispondere in primo luogo con la diversificazione delle informazioni, a misura della reale diversità del suo oggetto. Aina cita diverse indagini condotte negli Stati Uniti che illustrano la clamorosa, endemica e diffusa ignoranza del cittadino statunitense medio sull’Africa; difficile pensare che una indagine condotta in Europa, o in Italia, darebbe risultati troppo differenti, che il cittadino europeo o italiano medio sappia nominare almeno dieci paesi africani, o che non leghi le sue esili informazioni sul continente africano ad una minaccia epidemica (Aids o Ebola) o a episodi di genocidi (Ruanda, Sudan), informazioni che per loro natura hanno un evidente legame di causa-effetto circolare con lo stereotipo dell’Africa continente povero e pericoloso.
Non è la falsità delle immagini o delle condizioni veicolate in discussione: nessuno dubita delle enormi difficoltà in cui si dibatte il continente africano, né invenzioni sono le estese aree di povertà, di instabilità politica e sociale, né il proliferare di necropolitiche (Mbembe) e di efferate strategie neocoloniali. La questione è la natura unidimensionale dell’immagine dell’Africa: il processo riduzionista in atto che ne governa produzione e circolazione. Una ignoranza di cui da un lato è difficile negare la radice razzista, del razzismo come sistema ‘politico’ dell’ignoranza (e farebbe parte di una più consapevole ed efficace comprensione individuare il razzismo come elemento purtroppo non monopolizzato dai caucasici: elencando i razzismi inter-africani o inter-asiatici); dall’altro al deficit di conoscenza corrisponde una strategia fondata sull’emotività che muove la «compassion usury», ossia su una «inundation of collective emotionalism – to mobilise the public conscience’s and support»; una strategia che implica una rendita di «positionality», per la quale «development experts, Africanist scholars, and African collaborators in development fund campaigns all have authority in perpetuating dominant African images in the West»[3]. L’immagine è il mezzo funzionale al fine, calibrata sul numero degli acquirenti: l’Africa della povertà, in altri termini, è prigioniera dei suoi benefattori.
Tutto ciò reclama, evidentemente, la necessità di una pedagogia. Già più di venti anni fa, Solorzano aveva proposto un processo articolato in cinque punti per lavorare in controtendenza rispetto all’immagine dell’Africa dei benefattori. Il ragionamento è riferito all’educazione degli studenti, ma esso serba certamente un valore anche rispetto all’opinione pubblica dei paesi occidentali, nella misura in cui fenomeni come la poornography raggiungono una platea vastissima di spettatori o navigatori della rete. La riflessione, in questo caso, andrebbe fatta sui soggetti cui imputare una azione di decostruzione del regime riduzionista in cui è costretta l’immagine dell’Africa; una riflessione, anzitutto, sull’etica della comunicazione nella promozione del beneficio. Che è questione con caratteristiche differenti da quello che può riguardare i docenti di scuola o i professori universitari, pur risultando evidente che il perno comune su cui gira il problema è quello della conoscenza.
Perciò Solorzano, in primo luogo, faceva riferimento alla necessità di presentare e analizzare contenuti riferibili ad immagini alternative dell’Africa. La dimensione metropolitana, ad esempio, risulta regolarmente assente dalla comunicazione della poornography. In tal senso, ed è il secondo punto, proprio perché si è in tema di comunicazione di massa, un approccio qualificato al cinema africano – al cinema dei registi africani sull’Africa – fornirebbe elementi di miglior comprensione della realtà africana, pur con la cautela dovuta ad una fonte che in quanto fonte colta può essere fortemente coattiva nei confronti dei contenuti. Il terzo punto, muovendo come il secondo dalla necessità di leggere l’Africa a partire dal punto di vista degli africani, invita ad una strategia di comparazione che metta a confronti produzioni testuali sull’Africa di esperti non africani e testi prodotti dagli africani – con l’ulteriore elemento di interesse, si potrebbe aggiungere, dell’analisi delle faglie di conflitto interne. Quarto e quinto punto sono intimamente correlati: in un comune esercizio di pensiero critico, fare riflettere nel contesto occidentale gli africani sulla natura e i limiti delle tradizioni africane come fonte complessa – e storica – di identità, e gli occidentali sulla costruzione degli stereotipi razzisti come anch’essa, purtroppo, complessa e non meno storica costruzione di identità[4].
Poi, la poornography può avere anche un impiego tattico, non meno micidiale e dannoso, direttamente connesso a concrete dinamiche politiche. Un caso interessante è quello segnalato da F. Adyanga Akena a proposito di Kony 2012, un video di trenta minuti creato da una organizzazione non governativa californiana, la Invisible Children, attiva, fra l’altro, in Uganda settentrionale. Il video mostra i risultati di una serie di atti di violenza compiuti ai danni soprattutto di bambini, perpetrati dai ribelli della LRA (Lord Resistance Army) nel corso della guerra contro l’esercito della UPDF (Uganda People’s Defence Forces). Nel video si esortavano gli spettatori statunitensi a fare pressione sull’amministrazione Obama affinché gli Stati Uniti intervenissero militarmente in Uganda per catturare il leader dei ribelli, Joseph Kony, e portarlo dinanzi alla Corte Penale Internazionale dell’Aja. Diffuso in televisione e sui social media ai primi di marzo del 2012, il video ricevette il supporto immediato di numerosi personaggi del mondo del giornalismo e dello spettacolo. In un mese circa, undici milioni di spettatori lo guardarono: numeri che la politica non poteva ignorare. Si attiva persino il merchandising, con poster, t-shirts, braccialetti, stickers. Per Akena, il video Kony 2012 costituisce un caso esemplare di costruzione sociale della verità, e precisamente di «neo-colonial truths» che «ignore and silence African agency and the struggles of the Acholi people to confront the conflict and strive for peace on their own terms»[5].
L’esercito di Kony, formatosi nel 1987, lotta fino al 2006 contro l’UPDF nel nord dell’Uganda e nel Sudan meridionale, vagheggiando uno Stato teocratico retto sul Decalogo e sulle credenze Acholi. La strategia di guerra del LRA prevedeva il rapimento di bambini e ragazzi tra i sette e i sedici anni. Si arriva così alla stupefacente e tragica composizione di un esercito composto per più della metà da soldati-bambini: «this vulnerable age-group is often afraid to escape the LRA, for many reasons, including a desire to demonstrate respect to one’s elders and because of various psychological indoctrinations and intimidations they are subjected to, including sexual slavery and being forced to murder»; al tempo stesso, i campi di rifugio approntati dal governo ugandese per dare ricovero agli sfollati interni nel corso del conflitto si rivelano rimedi non dissimili dal male: «lacking the most basic social services, the NGO Civil Society Organization for Peace in Northern Uganda (CSOPNU) reports that each month in the IDP camps, more than 3.500 people died from easily preventable diseases, extreme violence and torture. Meanwhile hundred of childrens were being abducted, abused and killed in battle»[6]. Questo è l’immane disastro umanitario entro cui va collocato il video Kony-2012. A cui si accompagna, dopo il 2006, il secondo disastro dell’Operation Lightening Thunder, quando il governo ugandese, con l’appoggio di truppe congolesi e sudanesi, lancia una operazione militare contro i soldati del LRA rifugiati all’interno del Garamba National Park, nel Congo nord-orientale. L’operazione si rivela un fallimento e provoca subito dopo la reazione del LRA: novecento civili massacrati in poche settimane, 160 bambini rapiti e migliaia di civili spinti verso i centri urbani.
Questo il paesaggio martoriato nel quale il video Kony 2012 invitava nuovamente alla guerra; il video dichiarava guerra all’esercito del LRA, un esercito composto per la maggior parte da bambini rapiti, contro i quali si sarebbe in sostanza dovuta dirigere l’azione militare. La realtà più tragica del conflitto ugandese veniva celata: bambini e ragazzi al tempo stesso massacratori e vittime. Una semplice constatazione cronologica avrebbe permesso inoltre di verificare – altra omissione di palese stranezza – che le formazioni LRA non erano attive in Uganda settentrionale ormai da sei anni; mentre quando, fra il 1990 e il 2000, il conflitto civile aveva vissuto i suoi momenti peggiori, gli Stati Uniti non avevano espresso alcun interesse ad un coinvolgimento nel conflitto. Akena nota lo strano tempismo con la scoperta di nuovi giacimenti petroliferi nel nord e del sud dell’Uganda; quello che suona macroscopico è certamente il puntuale rivitalizzarsi della coltre africanista, della necessità dell’intervento bianco e occidentale (di un’altra gioventù armata) rispetto ad un’Africa non in grado di governare i propri conflitti, consegnata passivamente alla violenza endemica.
Note
[1] La formula compassion usury è di Ch. Quist-Adade e A. van Wyk, ed è citata da Raymond Olusesan Aina, Populorum Progressio’s Vision in an Unequal World: A Theological Ethical Evaluation from the Global South, in «Journal of Moral Theology», vol. 6, n. 1 (2017), p. 107.
[2] Raymond Olusesan Aina, Images of Africa and the Resilience of Ignorance, in «ZEP: Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik», 37 (2014) 4, p. 26.
[3] Ivi, pp. 28 e 29.
[4] Cfr. D. Solorzano, Images and Words that Wound: Critical Race Theory, Racial Stereotyping, and Teacher Education, in «Teacher Education Quarterly», 24 (1997), pp. 14-15.
[5] F. Adyanga Akena, Poornography and the entrenchment of western hegemony: deconstructing the Kony 2012 video, in «Socialist studies», 10 (1) 2014, p. 52.
[6] Ivi, pp. 53-54.
[VP23_novembre_2020_Pdf_Africa]
Nessun commento